Canta l’epistola
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
Tommasino Unzio è uscito dal seminario perché aveva perso la vocazione. Tommasino Unzio si è tolto la maschera, quella del suddiacono.
Ma senza la maschera chi è, cosa rimane di lui?
Il problema di Tommasino era che perdendo la vocazione lui perde anche l’eredità vincolata che uno zio prete gli aveva lasciato.
Infatti il denaro era vincolato al suo rimanere in seminario. Così Tommasino ritorna a casa e, tra la derisione dei compaesani e la rabbia del padre, cerca faticosamente la sua via d’uscita!
| – Avevate preso gli Ordini? – Tutti no. Fino al Suddiaconato. – Ah, suddiacono. E che fa il suddiacono? – Canta l’Epistola; regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo; amministra i vasi della Messa; tiene la patena avvolta nel velo in tempo del Canone. – Ah, dunque voi cantavate il Vangelo? – Nossignore. Il Vangelo lo canta il diacono; il suddiacono canta l’Epistola. – E vi allora cantavate l’Epistola? – Io? proprio io? Il suddiacono. – Canta l’Epistola? – Canta l’Epistola. Che c’era da ridere in tutto questo? Eppure, nella piazza aerea del paese, tutta frusciante di foglie secche, che s’oscurava e rischiarava a una rapida vicenda di nuvole e di sole, il vecchio dottor Fanti, rivolgendo quelle domande a Tommasino Unzio uscito or ora dal seminario senza più tonaca per aver perduto la fede, aveva composto la faccia caprigna a una tale aria, che tutti gli sfaccendati del paese, seduti in giro innanzi alla Farmacia dell’Ospedale, parte storcendosi e parte turandosi la bocca, s’erano tenuti a stento di ridere. Le risa erano prorotte squacquerate, appena andato via Tommasino inseguito da tutte quelle foglie secche, poi l’uno aveva preso a domandare all’altro: – Canta l’Epistola? E l’altro a rispondere: – Canta l’Epistola. E così a Tommasino Unzio, uscito suddiacono dal seminario senza più tonaca, per aver perduto la fede, era stato appiccicato il nomignolo di Canta l’Epistola. La fede si può perdere per centomila ragioni; e, in generale, chi perde la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto in cambio qualche guadagno; non foss’altro, quello della libertà di fare e dire certe cose che, prima, con la fede non riteneva compatibili. Quando però cagione della perdita non sia la violenza di appetiti terreni, ma sete d’anima che non riesca più a saziarsi nel calice dell’altare e nel fonte dell’acqua benedetta, difficilmente chi perde la fede è convinto d’aver guadagnato in cambio qualche cosa. Tutt’al più, lì per lì, non si lagna della perdita, in quanto riconosce d’aver perduto in fine una cosa che non aveva più per lui alcun valore. Tommasino Unzio, con la fede, aveva poi perduto tutto, anche l’unico stato che il padre gli potesse dare, mercé un lascito condizionato d’un vecchio zio sacerdote. Il padre, inoltre, non s’era tenuto di prenderlo a schiaffi, a calci, e di lasciarlo parecchi giorni a pane e acqua, e di scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperii. Ma Tommasino aveva sopportato tutto con dura e pallida fermezza, e aspettato che il padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci per fargli ritornar la fede e la vocazione. Non gli aveva fatto tanto male la violenza, quanto la volgarità dell’atto così contrario alla ragione per cui s’era spogliato dell’abito sacerdotale. Ma d’altra parte aveva compreso che le sue guance, le sue spalle, il suo stomaco dovevano offrire uno sfogo al padre per il dolore che sentiva anche lui, cocentissimo, della sua vita irreparabilmente crollata e rimasta come un ingombro lì per casa. Volle però dimostrare a tutti che non s’era spretato per voglia di mettersi “a fare il porco” come il padre pulitamente era andato sbandendo per tutto il paese. Si chiuse in sé, e non uscì più dalla sua cameretta, se non per qualche passeggiata solitaria o su per i boschi di castagni, fino al Pian della Britta, o giù per la carraia a valle, tra i campi, fino alla chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto, sempre assorto in meditazioni e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno. È vero intanto che il corpo, anche quando lo spirito si fissi in un dolore profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso lascia lo spirito così fissato e, zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per conto suo, a godere della buon’aria e dei cibi sani. Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi in breve e quasi per ischerno, mentre lo spirito gli s’immalinconiva e s’assottigliava sempre più nelle disperate meditazioni, con un corpo ben pasciuto e florido, da padre abate. Altro che Tommasino, adesso! Tommasone Canta l’Epistola. Ciascuno, a guardarlo, avrebbe dato ragione al padre. Ma si sapeva in paese come il povero giovine vivesse; e nessuna donna poteva dire d’essere stata guardata da lui, fosse pur di sfuggita. *** Non aver più coscienza d’essere, come una pietra, come una pianta; non ricordarsi più neanche del proprio nome; vivere per vivere, senza saper di vivere, come le bestie, come le piante; senza più affetti, né desiderii, né memorie, né pensieri, senza più nulla che désse senso e valore alla propria vita. Ecco: sdrajato lì su l’erba, con le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti, gonfie di sole; udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare, e nella voce di quel vento e in quel fragore sentire, come da un’infinita lontananza, la vanità d’ogni cosa e il tedio angoscioso della vita. Nuvole e vento. Eh, ma era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. Sa forse d’essere la nuvola? Né sapevan di lei l’albero e le pietre, che ignoravano anche se stessi. E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche – perché no? – pensare alla vicenda dell’acqua, che divien nuvola per ridivenir poi acqua di nuovo. E a spiegar questa vicenda bastava un povero professoruccio di fisica; ma a spiegare il perché del perché? Su nel bosco dei castagni, picchi d’accetta; giù nella cava, picchi di piccone. Mutilare la montagna; atterrare gli alberi, per costruire case. Lì, in quel borgo montano, altre case. Stenti, affanni, fatiche e pene d’ogni sorta, perché? per arrivare a un comignolo e per fare uscir poi da questo comignolo un po’ di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Ma davanti all’ampio spettacolo della natura, a quell’immenso piano verde di querci e d’ulivi e di castagni, digradante dalle falde del Cimino fino alla valle tiberina laggiù laggiù, sentiva a poco a poco rasserenarsi in una blanda smemorata mestizia. Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i desiderii degli uomini gli apparivano vani e transitorii di fronte al sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi, impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano nell’eternità della natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle tiberina, lontani lontani, sfumanti all’orizzonte, lievi e quasi aerei nel tramonto. Oh ambizioni degli uomini! Che grida di vittoria, perché l’uomo s’era messo a volare come un uccellino! Ma ecco qua un uccellino come vola: è la facilità più schietta e lieve, che s’accompagna spontanea a un trillo di gioia. Pensare adesso al goffo apparecchio rombante, e allo sgomento, all’ansia, all’angoscia mortale dell’uomo che vuoi fare l’uccellino! Qua un frullo e un trillo; là un motore strepitoso e puzzolente, e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s’arresta; addio uccellino! – Uomo, – diceva Tommasino Unzio lì sdraiato sull’erba, – lascia di volare. Perché vuoi volare? E quando hai volato? *** D’un tratto, come una raffica, corse per tutto il paese una notizia che sbalordì tutti: Tommasino Unzio, Canta l’Epistola, era stato prima schiaffeggiato e poi sfidato a duello dal tenente De Venera, comandante il distaccamento, perché, senza voler dare alcuna spiegazione, aveva confermato d’aver detto: – Stupida! – in faccia alla signorina Olga Fanelli, fidanzata del tenente, la sera avanti, lungo la via di campagna che conduce alla chiesetta di Santa Maria di Loreto. Era uno sbalordimento misto d’ilarità, che pareva s’appigliasse a un’interrogazione su questo o quel dato della notizia, per non precipitare di botto nell’incredulità. -Tommasino? – Sfidato a duello? – Stupida, alla signorina Fanelli? – Confermato? – Senza spiegazioni? – E ha accettato la sfida? -Eh, perdio, schiaffeggiato! -E si batterà? -Domani, alla pistola. -Col tenente De Venera alla pistola? – Alla pistola. E dunque il motivo doveva esser gravissimo. Pareva a tutti non si potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora segreta. E forse le aveva gridato in faccia “Stupida!” perché ella, invece di lui, amava il tenente De Venera. Era chiaro! E veramente tutti in paese giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel ridicolissimo De Venera. Ma non lo poteva credere lui, naturalmente, il De Venera; e perciò aveva preteso una spiegazione. Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con le lagrime agli occhi che non poteva esser quella la ragione dell’ingiuria, perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il quale del resto non aveva mai neppure alzato gli occhi a guardarla; e mai e poi mai, neppure per un minimo segno, le aveva dato a vedere di covar per lei quella furiosa passione segreta, che tutti dicevano. Ma che! no! non quella: qualche altra ragione doveva esserci sotto! Ma quale? Per niente non si grida: – Stupida! – in faccia a una signorina. Se tutti, e in ispecie il padre e la madre, i due padrini, il De Venera e la signorina stessa si struggevano di saper la vera ragione dell’ingiuria; più di tutti si struggeva Tommasino di non poterla dire, sicuro com’era che, se l’avesse detta, nessuno la avrebbe creduta, e che anzi a tutti sarebbe sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile l’irrisione. Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melanconia, si fosse preso d’una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano, fino alle lagrime talvolta. Oh! in quanti modi si nasceva, e per una volta sola, e in quella data forma, unica, perché mai due forme non erano uguali, e così per poco tempo, per un giorno solo talvolta, e in un piccolissimo spazio, avendo tutt’intorno, ignoto, l’enorme mondo, la vacuità enorme e impenetrabile del mistero dell’esistenza. Formichetta, si nasceva, e moscerino, e filo d’erba. Una formichetta, nel mondo! nel mondo, un moscerino, un filo d’erba. Il filo d’erba nasceva, cresceva, fioriva, appassiva; e via per sempre; mai più, quello; mai più! *** Ora, da circa un mese, egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d’un filo d’erba appunto: d’un filo d’erba tra due grigi macigni tigrati di mosco, dietro la chiesetta abbandonata di Santa Maria di Loreto. Lo aveva seguito, quasi con tenerezza materna, nel crescer lento tra altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere dapprima timido, nella sua tremula esilità, oltre i due macigni ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d’ammirar lo spettacolo che si spalancava sotto, della verde, sconfinata pianura; poi, su, su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto rossigno in cima, come una cresta di galletto. E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita, aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d’aria; trepidando era accorso in qualche giorno di forte vento, o per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una greggiola di capre, che ogni giorno, alla stess’ora, passava dietro la chiesetta e spesso s’indugiava un po’ a strappare tra i macigni qualche ciuffo d’erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d’erba. E la gioia di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì, col suo spavaldo pennacchietto in cima, era ineffabile. Lo carezzava, lo lisciava con due dita delicatissime, quasi lo custodiva con l’anima e col fiato; e, nel lasciarlo, la sera, lo affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare, perché con tutte le altre lo vegliassero durante la notte. E proprio, con gli occhi della mente, da lontano, vedeva quel suo filo d’erba, tra i due macigni, sotto le stelle fitte fitte, sfavillanti nel cielo nero, che lo vegliavano. Ebbene, quel giorno, venendo alla solita ora per vivere un’ora con quel suo filo d’erba, quand’era già a pochi passi dalla chiesetta, aveva scorto dietro a questa, seduta su uno di quei due macigni, la signorina Olga Fanelli, che forse stava lì a riposarsi un po’, prima di riprendere il cammino. Si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare ch’ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E difatti, poco dopo, la signorina era sorta in piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui: s’era guardata un po’ attorno: poi, distrattamente, allungando la mano, aveva strappato giusto quel filo d’erba e se l’era messo tra i denti col pennacchietto ciondolante. Tommasino Unzio s’era sentito strappar l’anima, e irresistibilmente le aveva gridato: – Stupida! – quand’ella gli era passata davanti, con quel gambo in bocca. Ora, poteva egli confessare d’avere ingiuriato così quella signorina per un filo d’erba? E il tenente De Venera lo aveva schiaffeggiato. Tommasino era stanco dell’inutile vita, stanco dell’ingombro di quella sua stupida carne, stanco della baja che tutti gli davano e che sarebbe diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le condizioni del duello fossero gravissime. Sapeva che il tenente De Venera era un valentissimo tiratore. Ne dava ogni mattina la prova, durante le istruzioni del Tiro a segno. E volle battersi alla pistola, la mattina appresso, all’alba, proprio là, nel recinto del Tiro a segno. *** Una palla in petto. La ferita dapprima, non parve tanto grave; poi s’aggravò. La palla aveva forato il polmone. Una gran febbre; il delirio. Quattro giorni e quattro notti di cure disperate. La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono che non c’era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo che, almeno prima di morire, volesse ritornare in grazia di Dio. E Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a ricevere un confessore. Quando questo, al letto di morte, gli chiese: – Ma perché, figliuolo mio? perché? Tommasino, con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro ch’era anche sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente: – Padre, per un filo d’erba. E tutti credettero ch’egli fino all’ultimo seguitasse a delirare. |
Il treno ha fischiato
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
Il treno ha fischiato è una novella tratta dalla raccolta Novelle per un anno di Luigi Pirandello.
Il signor Belluca è un impiegato obbediente, un contabile mansueto e preciso. Un bel giorno però inizia a comportarsi in modo insolito, al punto tale che i colleghi e il capoufficio, credendolo pazzo, lo fanno ricoverare in un ospedale psichiatrico. Neppure i dottori che lo hanno in cura riescono a comprendere il significato della frase che egli continua ostinatamente a ripetere. Sarà il vicino di casa a spiegare il senso di questa strana follia.
Questa è una delle novelle in cui Pirandello ci indica che esiste una via d’uscita, anche nelle situazioni più drammatiche.
| Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: – Frenesia, frenesia. – Encefalite. – Infiammazione della membrana. – Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. – Morrà? Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no… – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. Farnetica… – Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale Perché uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. Circoscritto… sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri, partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, come se non le sentisse più, avvezzo com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una improvvisa alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto di fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare, d’una ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: – E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza, aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare… – Il treno? – Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo… Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio – che quella sera doveva essere di malumore – urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: – Si parte, si parte… Signori, per dove? per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell’improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: – Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio: «A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita “impossibile”, la cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo è “impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima». Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta; l’altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre soltanto. Con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt’e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti della casa. Letti ampii, matrimoniali; ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch’esse tra loro, perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine, si faceva silenzio, e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. – Magari! – diceva – Magari! Signori, Belluca s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte. C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti… sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le foreste… E, dunque, lui – ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capoufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia… oppure oppure… nelle foreste del Congo: – Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… |
Commento alla novella -Il treno ha fischiato
Il relativismo di Pirandello
Il racconto mostra i diversi punti di vista nella vicenda del contabile Belluca. Questa molteplicità di punti di vista esprime una problematica esistenziale:
- da un lato come si è,
- dall’altro come si appare.
Questo è un concetto che Pirandello affronta spesso: la realtà non è unica, né univoca, ma è sempre interpretabile in vari modi.
Per i suoi colleghi e per i medici Belluca è pazzo: infatti nell’ambiente di lavoro non si riesce a comprendere che i suoi gesti inattesi e la ribellione al capo.
Per Belluca è infatti indispensabile, ad un tratto liberarsi dalla maschera impostagli dalla società. Tolta la maschera del “lavoratore da soma” i colleghi gli attribuiscono una nuova «forma», una nuova maschera,
quella del pazzo o del malato “Farneticava… frenesia… encefalite”. Indipendentemente da quale sia la maschera attribuitagli, la società lo esclude e lo isola.
Ma una voce fuori campo, fuori dal contesto di lavoro e fuori dalla famiglia, quella del vicino di casa racconta la realtà del povero Belluca.
Questi infatti conosce la sua situazione familiare e perciò ipotizza che l’improvvisa pazzia possa essere facilmente spiegata. Una volta ricostruita la vicenda si può capire che la pazzia di Belluca è come la coda di un mostro, ossia il risultato finale, cioè la coda, della sua esistenza alienata. paragonata ad un mostro.
La spiegazione di quanto è successo è fornita direttamente dal protagonista:
- l’improvviso fischio notturno del treno ha messo in moto il suo viaggio liberatorio;
- l’immensità dello spazio aperto, simbolo della «vita», irrompe nell’angustiosa «forma» della sua vita fatta dello spazio chiuso della casa e dell’ufficio;
- la fuga nella fantasia è occasione di riscatto dalle umiliazioni quotidiane, cui ora può ribellarsi ritrovando l’autenticità del proprio essere.
Ma Belluca non scappa davvero, vuole tornare al suo lavoro. Solo che ora, ora che il treno ha fischiato… egli sarà un uomo nuovo proprio perché, ogni tanto, potrà evadere dallo squallore della vita attraverso l’immaginazione. Ha trovato la sua personale via d’uscita.
Vita e forma
Il racconto sviluppa il tema del contrasto:
- tra realtà e apparenza,
- tra come veramente siamo e quello che gli altri vedono di noi,
- tra quello che siamo e quello che gli altri vogliono vedere in noi,
- tra quello che vogliamo noi e quello che si aspettano gli altri.
Questo conflitto tra «vita» e «forma» si esprime, nelle novelle di Pirandello, attraverso situazioni paradossali come quella di Belluca. Gli altri vedono il protagonista in una dimensione “cristallizzata”, una forma, ma dietro questa forma fatta di abitudini e di lavoro, si nasconde un enorme disagio, una terribile sofferenza. Esplode quindi, all’improvviso in Belluca il desiderio di uscire da questa situazione, di ricercare la propria autenticità. Di qui nasce il dramma dell’incomunicabilità.
Belluca appare agli altri come un pazzo, ma lui non è pazzo e non si sente tale. Il fischio del treno arriva all’improvviso e gli rivela l’assurdità di quella sua esistenza non vissuta.
La voce narrante e il punto di vista
Come molte novelle di Pirandello, il lettore rimane sorpreso e stupito, interrogativo.
La novella si apre in medias res, cioè nel cuore della storia, con un racconto in terza persona. Gli elementi per la comprensione di quanto accaduto sono forniti, poi, in flashback.
A metà racconto la parola passa al narratore interno, il vicino di casa, che chiarisce al lettore i veri motivi del comportamento di Belluca.
In quel momento due visioni si contrappongono: quella dei colleghi, che lo vedono solo dal loro punti di vista, e quella del vicino che conosce la situazione di Belluca. La versione del vicino viene poi confermata e spiegata dal protagonista stesso.
Domande sul testo
| 1. Spiega per quale ragione l’episodio apparentemente banale che dà il titolo alla novella, il fischio del treno, svolge un ruolo scatenante nella presunta follia di Belluca. Rispondi con opportuni riferimenti al testo. 2. Alcuni termini esprimono la condizione disumana di Belluca agli occhi dei colleghi: individuali e spiega che cosa significa la metafora del “vecchio somaro”. 3. A quale situazione vuole sottrarsi Belluca attraverso la fantasia? 4. Che tipo di vita conduce quando sente fischiare il treno? 5. Dopo che il treno ha fischiato, come si manifesta il cambiamento di Belluca? Quali comportamenti assume? 6. Per quale ragione possiamo affermare che il protagonista della novella è un personaggio tragicomico? 7. Rileggi le riflessioni del narratore sulla possibile spiegazione del gesto di Belluca e sulla sua apparente “mostruosità”; spiega la metafora della coda del mostro. 8. Descrivi il narratore ponendo attenzione ai seguenti aspetti: • la sua identità; • la sua interpretazione del gesto di Belluca, confrontata anche con quella dei colleghi e del capo-ufficio. 9. Quale significato assume la ribellione di Belluca in rapporto al tema del contrasto fra vita e forma? 10. Come riesce Pirandello a mostrarci la sua idea che la realtà è relativa? 11. Belluca ha trovato la sua personale via d’uscita. Quante volte, anche noi abbiamo bisogno di evasione, senza per questo voler rivoluzionare la nostra vita? 12. Quale nostra personale via d’uscita ci permette poi di indossare le nostre maschere quotidiane in serenità? |
Altri commenti da consultare
https://library.weschool.com/lezione/luigi-pirandello-novella-il-treno-ha-fischiato-sintesi-trama-6272.html
L’eresia catara
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
Bernardino Lamis, docente di storia delle religioni alla Sapienza di Roma, si propone di controbattere con una memorabile lezione un collega tedesco che aveva contestato una sua pubblicazione sull’eresia dei catari.
Lamis, gravemente miope e afflitto da vari problemi familiari non è disposto a lasciar correre! Il professore sa che il suo corso è seguito solo da due studenti, ma è convinto che data l’importanza della lezione, i suoi due fedeli ascoltatori avrebbero convinto studenti a presenziare
In una giornata uggiosa, buia e tempestosa il professore, finalmente, tiene la sua Lectio, ma …
| Bernardino Lamis, professore ordinario di storia delle religioni, socchiudendo gli occhi addogliati e, come soleva nelle piú gravi occasioni, prendendosi il capo inteschiato tra le gracili mani tremolanti che pareva avessero in punta, invece delle unghie, cinque rosee conchigliette lucenti, annunziò ai due soli alunni che seguivano con pertinace fedeltà il suo corso: – Diremo, o signori, nella ventura lezione, dell’eresia catara. Uno de’ due studenti, il Ciotta – bruno ciociaretto di Guarcino, tozzo e solido – digrignò i denti con fiera gioja e si diede una violenta fregatina alle mani. L’altro, il pallido Vannícoli, dai biondi capelli irti come fili di stoppia e dall’aria spirante, appuntí invece le labbra, rese piú dolente che mai lo sguardo dei chiari occhi languidi e stette col naso come in punto a annusar qualche odore sgradevole, per significare che era compreso della pena che al venerato maestro doveva certo costare la trattazione di quel tema, dopo quanto glien’aveva detto privatamente. (Perché il Vannícoli credeva che il professor Lamis quand’egli e il Ciotta, finita la lezione, lo accompagnavano per un lungo tratto di via verso casa, si rivolgesse unicamente a lui, solo capace d’intenderlo.) E difatti il Vannícoli sapeva che da circa sei mesi era uscita in Germania (Halle a. S.) una mastodontica monografia di Hans von Grobler su l’Eresia Catara, messa dalla critica ai sette cieli, e che su lo stesso argomento, tre anni prima, Bernardino Lamis aveva scritto due poderosi volumi, di cui il von Grobler mostrava di non aver tenuto conto, se non solo una volta, e di passata, citando que’ due volumi, in una breve nota; per dirne male. Bernardino Lamis n’era rimasto ferito proprio nel cuore; e piú s’era addolorato e indignato della critica italiana che, elogiando anch’essa a occhi chiusi il libro tedesco, non aveva minimamente ricordato i due volumi anteriori di lui, né speso una parola per rilevare l’indegno trattamento usato dallo scrittore tedesco a uno scrittor paesano. Piú di due mesi aveva aspettato che qualcuno, almeno tra i suoi antichi scolari, si fosse mosso a difenderlo; poi, tuttoché – secondo il suo modo di vedere – non gli fosse parso ben fatto, s’era difeso da sé, notando in una lunga e minuziosa rassegna, condita di fine ironia, tutti gli errori piú o meno grossolani in cui il von Grobler era caduto, tutte le parti che costui s’era appropriate della sua opera senza farne menzione, e aveva infine raffermato con nuovi e inoppugnabili argomenti le proprie opinioni contro quelle discordanti dello storico tedesco. Questa sua difesa, però, per la troppa lunghezza e per lo scarso interesse che avrebbe potuto destare nella maggioranza dei lettori, era stata rifiutata da due riviste; una terza se la teneva da piú d’un mese, e chi sa quanto tempo ancora se la sarebbe tenuta, a giudicare dalla risposta punto garbata che il Lamis, a una sua sollecitazione, aveva ricevuto dal direttore. Sicché dunque davvero Bernardino Lamis aveva ragione, uscito dall’Università, di sfogarsi quel giorno amaramente coi due suoi fedeli giovani che lo accompagnavano al solito verso casa. E parlava loro della spudorata ciarlataneria che dal campo della politica era passata a sgambettare in quello della letteratura, prima, e ora, purtroppo, anche nei sacri e inviolabili dominii della scienza; parlava della servilità vigliacca radicata profondamente nell’indole del popolo italiano, per cui è gemma preziosa qualunque cosa venga d’oltralpe o d’oltremare e pietra falsa e vile tutto ciò che si produce da noi; accennava infine agli argomenti piú forti contro il suo avversario, da svolgere nella ventura lezione. E il Ciotta, pregustando il piacere che gli sarebbe venuto dall’estro ironico e bilioso del professore, tornava a fregarsi le mani, mentre il Vannícoli, afflitto, sospirava. A un certo punto il professor Lamis tacque e prese un’aria astratta: segno, questo, per i due scolari, che il professore voleva esser lasciato solo. Ogni volta, dopo la lezione, si faceva una giratina per sollievo giú per la piazza del Pantheon, poi su per quella della Minerva, attraversava Via dei Cestari e sboccava sul Corso Vittorio Emanuele. Giunto in prossimità di Piazza San Pantaleo, prendeva quell’aria astratta, perché solito – prima di imboccare la Via del Governo Vecchio, ove abitava – d’entrare (furtivamente, secondo la sua intenzione) in una pasticceria, donde poco dopo usciva con un cartoccio in mano. I due scolari sapevano che il professor Lamis non aveva da fare neppur le spese a un grillo, e non si potevano perciò capacitare della compera di quel cartoccio misterioso, tre volte la settimana. Spinto dalla curiosità, il Ciotta era finanche entrato un giorno nella pasticceria a domandare che cosa il professore vi comperasse. – Amaretti, schiumette e bocche di dama. E per chi serviranno? Il Vannícoli diceva per i nipotini. Ma il Ciotta avrebbe messo le mani sul fuoco che servivano proprio per lui, per il professore stesso; perché una volta lo aveva sorpreso per via nel mentre che si cacciava una mano in tasca per trarne fuori una di quelle schiumette e doveva già averne un’altra in bocca, di sicuro, la quale gli aveva impedito di rispondere a voce al saluto che lui gli aveva rivolto. – Ebbene, e se mai, che c’è di male? Debolezze! – gli aveva detto, seccato, il Vannícoli, mentre da lontano seguiva con lo sguardo languido il vecchio professore, il quale se ne andava pian piano, molle molle, strusciando le scarpe. Non solamente questo peccatuccio di gola, ma tante e tant’altre cose potevano essere perdonate a quell’uomo che, per la scienza, s’era ridotto con quelle spalle aggobbate che pareva gli volessero scivolare e fossero tenute su, penosamente, dal collo lungo, proteso come sotto un giogo. Tra il cappello e la nuca la calvizie del professor Lamis si scopriva come una mezza luna cuojacea; gli tremolava su la nuca una rada zazzeretta argentea, che gli accavallava di qua e di là gli orecchi e seguitava barba davanti – su le gote e sotto il mento – a collana. Né il Ciotta né il Vannícoli avrebbero mai supposto che in quel cartoccio Bernardino Lamis si portava a casa tutto il suo pasto giornaliero. Due anni addietro, gli era piombata addosso da Napoli la famiglia d’un suo fratello, morto colà improvvisamente: la cognata, furia d’inferno, con sette figliuoli, il maggiore dei quali aveva appena undici anni. Notare che il professor Lamis non aveva voluto prender moglie per non esser distratto in alcun modo dagli studii. Quando, senz’alcun preavviso, s’era veduto innanzi quell’esercito strillante, accampato sul pianerottolo della scala, davanti la porta, a cavallo d’innumerevoli fagotti e fagottini, era rimasto allibito. Non potendo per la scala, aveva pensato per un momento di scappare buttandosi dalla finestra. Le quattro stanzette della sua modesta dimora erano state invase; la scoperta d’un giardinetto, unica e dolce cura dello zio, aveva suscitato un tripudio frenetico nei sette orfani sconsolati, come li chiamava la grassa cognata napoletana. Un mese dopo, non c’era piú un filo d’erba in quel giardinetto. Il professor Lamis era diventato l’ombra di se stesso: s’aggirava per lo studio come uno che non stia piú in cervello, tenendosi pur nondimeno la testa tra le mani quasi per non farsela portar via anche materialmente da quegli strilli, da quei pianti, da quel pandemonio imperversante dalla mattina alla sera. Ed era durato un anno, per lui, questo supplizio, e chi sa quant’altro tempo ancora sarebbe durato, se un giorno non si fosse accorto che la cognata, non contenta dello stipendio che a ogni ventisette del mese egli le consegnava intero, ajutava dal giardinetto il maggiore dei figliuoli a inerpicarsi fino alla finestra dello studio, chiuso prudentemente a chiave, per fargli rubare i libri: – Belli grossi, neh, Gennarie’, belli grossi e nuovi! Mezza la sua biblioteca era andata a finire per pochi soldi sui muricciuoli. Indignato, su le furie, quel giorno stesso, Bernardino Lamis con sei ceste di libri superstiti e tre rustiche scansie, un gran crocefisso di cartone, una cassa di biancheria, tre seggiole, un ampio seggiolone di cuojo, la scrivania alta e un lavamano, se n’era andato ad abitare – solo – in quelle due stanzette di via Governo Vecchio, dopo aver imposto alla cognata di non farsi vedere mai piú da lui. Le mandava ora per mezzo d’un bidello dell’Università, puntualmente ogni mese, lo stipendio, di cui tratteneva soltanto lo stretto necessario per sé. Non aveva voluto prendere neanche una serva a mezzo servizio, temendo che si mettesse d’accordo con la cognata. Del resto, non ne aveva bisogno. Non s’era portato nemmeno il letto, dormiva con uno scialletto su le spalle, avvoltolato in una coperta di lana, entro il seggiolone. Non cucinava. Seguace a modo suo della teoria del Fletcher, si nutriva con poco, masticando molto. Votava quel famoso cartoccio nelle due ampie tasche dei calzoni, metà qua, metà là, e mentre studiava o scriveva, in piedi com’era solito, mangiucchiava o un amaretto o una schiumetta o una bocca di dama. Se aveva sete, acqua. Dopo un anno di quell’inferno, si sentiva ora in paradiso. Ma era venuto il von Grobler con quel suo libraccio su l’Eresia Catara a guastargli le feste. Quel giorno, appena rincasato, Bernardino Lamis si rimise al lavoro, febbrilmente. Aveva innanzi a sé due giorni per finir di stendere quella lezione che gli stava tanto a cuore. Voleva che fosse formidabile. Ogni parola doveva essere una frecciata per quel tedescaccio von Grobler. Le sue lezioni egli soleva scriverle dalla prima parola fino all’ultima, in fogli di carta protocollo, di minutissimo carattere. Poi, all’Università, le leggeva con voce lenta e grave, reclinando indietro il capo, increspando la fronte e stendendo le pàlpebre per potere vedere attraverso le lenti insellate su la punta del naso, dalle cui narici uscivano due cespuglietti di ispidi peli grigi liberamente cresciuti. I due fidi scolari avevano tutto il tempo di scrivere quasi sotto dettatura. Il Lamis non montava mai in cattedra: sedeva umilmente davanti al tavolino sotto. I banchi, nell’aula, erano disposti in quattro ordini, ad anfiteatro. L’aula era buja, e il Ciotta e il Vannícoli all’ultimo ordine, uno di qua, l’altro di là, ai due estremi, per aver luce dai due occhi ferrati che si aprivano in alto. Il professore non li vedeva mai durante la lezione: udiva soltanto il raspío delle loro penne frettolose. Là, in quell’aula, poiché nessuno s’era levato in sua difesa, lui si sarebbe vendicato della villania di quel tedescaccio, dettando una lezione memorabile. Avrebbe prima esposto con succinta chiarezza l’origine, la ragione, l’essenza, l’importanza storica e le conseguenze dell’eresia catara, riassumendole dai suoi due volumi; si sarebbe poi lanciato nella parte polemica, avvalendosi dello studio critico che aveva già fatto sul libro del von Grobler. Padrone com’era della materia, e col lavoro già pronto, sotto mano, a una sola fatica sarebbe andato incontro: a quella di tenere a freno la penna. Con l’estro della bile, avrebbe scritto in due giorni, su quell’argomento, due altri volumi piú poderosi dei primi. Doveva invece restringersi a una piana lettura di poco piú di un’ora: riempire cioè di quella sua minuta scrittura non piú di cinque o sei facciate di carta protocollo. Due le aveva già scritte. Le tre o quattro altre facciate dovevano servire per la parte polemica. Prima d’accingervisi, volle rileggere la bozza del suo studio critico sul libro del von Grobler. La trasse fuori dal cassetto della scrivania, vi soffiò su per cacciar via la polvere, con le lenti già su la punta del naso, e andò a stendersi lungo lungo sul seggiolone. A mano a mano, leggendo, se ne compiacque tanto, che per miracolo non si trovò ritto in piedi su quel seggiolone; e tutte, una dopo l’altra, in men d’un’ora, s’era mangiato inavvertitamente le schiumette che dovevano servirgli per due giorni. Mortificato, trasse fuori la tasca vuota, per scuoterne la sfarinatura. Si mise senz’altro a scrivere, con l’intenzione di riassumere per sommi capi quello studio critico. A poco a poco però, scrivendo, si lasciò vincere dalla tentazione d’incorporarlo tutto quanto di filo nella lezione, parendogli che nulla vi fosse di superfluo, né un punto né una virgola. Come rinunziare, infatti, a certe espressioni d’una arguzia cosí spontanea e di tanta efficacia? a certi argomenti cosí calzanti e decisivi? E altri e altri ancora gliene venivano, scrivendo, piú lucidi, piú convincenti, a cui non era del pari possibile rinunziare. Quando fu alla mattina del terzo giorno, che doveva dettar la lezione, Bernardino Lamis si trovò davanti, sulla scrivania ben quindici facciate fitte fitte, invece di sei. Si smarrí. Scrupolosissimo nel suo officio, soleva ogni anno, in principio, dettare il sommario di tutta la materia d’insegnamento che avrebbe svolto durante il corso, e a questo sommario si atteneva rigorosissimamente. Già aveva fatto, per quella malaugurata pubblicazione del libro del von Grobler, una prima concessione all’amor proprio offeso, entrando quell’anno a parlare quasi senza opportunità dell’eresia catara. Piú d’una lezione, dunque, non avrebbe potuto spenderci. Non voleva a nessun costo che si dicesse che per bizza o per sfogo il professor Lamis parlava fuor di proposito o piú del necessario su un argomento che non rientrava se non di lontano nella materia dell’annata. Bisognava dunque, assolutamente, nelle poche ore che gli restavano, ridurre a otto, a nove facciate al massimo, le quindici che aveva scritte. Questa riduzione gli costò un cosí intenso sforzo intellettuale, che non avvertí nemmeno alla grandine, ai lampi, ai tuoni d’un violentissimo uragano che s’era improvvisamente rovesciato su Roma. Quando fu su la soglia del portoncino di casa, col suo lungo rotoletto di carta sotto il braccio, pioveva a diluvio. Come fare? Mancavano appena dieci minuti all’ora fissata per la lezione. Rifece le scale, per munirsi d’ombrello, e si avviò sotto quell’acqua, riparando alla meglio il rotoletto di carta, la sua “formidabile” lezione. Giunse all’Università in uno stato compassionevole: zuppo da capo a piedi. Lasciò l’ombrello nella bacheca del portinajo; si scosse un po’ la pioggia di dosso, pestando i piedi; s’asciugò la faccia e salí al loggiato. L’aula – buja anche nei giorni sereni – pareva con quel tempo infernale una catacomba; ci si vedeva a mala pena. Non di meno, entrando, il professor Lamis, che non soleva mai alzare il capo, ebbe la consolazione d’intravedere in essa, cosí di sfuggita, un insolito affollamento, e ne lodò in cuor suo i due fidi scolari che evidentemente avevano sparso tra i compagni la voce del particolare impegno con cui il loro vecchio professore avrebbe svolto quella lezione che tanta e tanta fatica gli era costata e dove tanto tesoro di cognizioni era con sommo sforzo racchiuso e tanta arguzia imprigionata. In preda a una viva emozione, posò il cappello e montò, quel giorno, insolitamente, in cattedra. Le gracili mani gli tremolavano talmente, che stentò non poco a inforcarsi le lenti sulla punta del naso. Nell’aula il silenzio era perfetto. E il professor Lamis, svolto il rotolo di carta, prese a leggere con voce alta e vibrante, di cui egli stesso restò meravigliato. A quali note sarebbe salito, allorché, finita la parte espositiva per cui non era acconcio quel tono di voce, si sarebbe lanciato nella polemica? Ma in quel momento il professor Lamis non era piú padrone di sé. Quasi morso dalle vipere del suo stile, sentiva di tratto in tratto le reni fènderglisi per lunghi brividi e alzava di punto in punto la voce e gestiva, gestiva. Il professor Bernardino Lamis, cosí rigido sempre, cosí contegnoso, quel giorno, gestiva! Troppa bile aveva accumulato in sei mesi, troppa indignazione gli avevano cagionato la servilità, il silenzio della critica italiana; e questo ora, ecco, era per lui il momento della rivincita! Tutti quei bravi giovani, che stavano ad ascoltarlo religiosamente, avrebbero parlato di questa sua lezione, avrebbero detto che egli era salito in cattedra quel giorno perché con maggior solennità partisse dall’Ateneo di Roma la sua sdegnosa risposta non al von Grobler soltanto, ma a tutta quanta la Germania. Leggeva cosí da circa tre quarti d’ora, sempre piú acceso e vibrante, allorché lo studente Ciotta, che nel venire all’Università era stato sorpreso da un piú forte rovescio d’acqua e s’era riparato in un portone, s’affacciò quasi impaurito all’uscio dell’aula. Essendo in ritardo, aveva sperato che il professor Lamis con quel tempo da lupi non sarebbe venuto a far lezione. Giú, poi, nella bacheca del portinajo, aveva trovato un bigliettino del Vannícoli che lo pregava di scusarlo presso l’amato professore perché “essendogli la sera avanti smucciato un piede nell’uscir di casa, aveva ruzzolato la scala, s’era slogato un braccio e non poteva perciò, con suo sommo dolore, assistere alla lezione”. A chi parlava, dunque, con tanto fervore il professor Bernardino Lamis? Zitto zitto, in punta di piedi, il Ciotta varcò la soglia dell’aula e volse in giro lo sguardo. Con gli occhi un po’ abbagliati dalla luce di fuori, per quanto scarsa, intravide anche nell’aula numerosi studenti, e ne rimase stupito. Possibile? Si sforzò a guardar meglio. Una ventina di soprabiti impermeabili, stesi qua e là a sgocciolare nella buja aula deserta, formavano quel giorno tutto l’uditorio del professor Bernardino Lamis. Il Ciotta li guardò, sbigottito, sentí gelarsi il sangue, vedendo il professore leggere cosí infervorato a quei soprabiti la sua lezione, e si ritrasse quasi con paura. Intanto, terminata l’ora, dall’aula vicina usciva rumorosamente una frotta di studenti di legge, ch’erano forse i proprietarii di quei soprabiti. Subito il Ciotta, che non poteva ancora riprender fiato dall’emozione, stese le braccia e si piantò davanti all’uscio per impedire il passo. – Per carità, non entrate! C’è dentro il professor Lamis. – E che fa? – domandarono quelli, meravigliati dell’aria stravolta del Ciotta. Questi si pose un dito sulla bocca, poi disse piano, con gli occhi sbarrati: – Parla solo! Scoppiò una clamorosa irrefrenabile risata. Il Ciotta chiuse lesto lesto l’uscio dell’aula, scongiurando di nuovo: – Zitti, per carità, zitti! Non gli date questa mortificazione, povero vecchio! Sta parlando dell’eresia catara! Ma gli studenti, promettendo di far silenzio, vollero che l’uscio fosse riaperto, pian piano, per godersi dalla soglia lo spettacolo di quei loro poveri soprabiti che ascoltavano immobili, sgocciolanti neri nell’ombra, la formidabile lezione del professor Bernardino Lamis. – . ma il manicheismo, o signori, il manicheismo, in fondo, che cosa è? Ditelo voi! Ora, se i primi Albigesi, a detta del nostro illustre storico tedesco, signor Hans von Grobler . |
La carriola
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
Un avvocato e professore di diritto, uomo saggio e rispettato, racconta, con fare molto misterioso, una mania che ha da qualche giorno e che lo tormenta segretamente.
Un giorno, mentre sta viaggiando in treno di ritorno da un viaggio di lavoro, pone il suo sguardo fuori dal finestrino.
Ma non vede nulla perché un pensiero gli si è affacciato alla mente …
| Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso. Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro (e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei) che questo mio atto non fosse scoperto. Giacché, se scoperto, il danno che ne verrebbe, e non soltanto a me, sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse m’acchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero, atterriti, in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l’onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m’assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza; d’altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d’esser tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa, dall’esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno piú serio dell’altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d’avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto si scoprisse! La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia, da qualche giorno, non mi sento piú sicuro. Sono costernato e inquieto. Perché, se è vero che non può parlare, mi guarda, mi guarda con tali occhi e in questi occhi è così chiaro il terrore, che temo qualcuno possa da un momento all’altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell’atto ch’io compio, può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi, a cui la vita si sia rivelata come d’un tratto s’è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere, non è facile. Mi proverò. *** Ritornavo, quindici giorni or sono, da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei piú gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m’opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po’ di distrazione, che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L’unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un’altra nuova. M’ero perciò portate in treno, nella busta di cuojo, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano; vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra. Ma io, certo, non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che, a poco a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m’occupava, senza che per questo, intanto, mi s’avvistasse di piú lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai piú a nulla: restai, per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida. Ariosa. Lo spirito mi s’era quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chi sa come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d’una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, non qua, non ora, ma là, in quell’infinita lontananza; d’una vita remota, che forse era stata sua, non sapeva come né quando; di cui gli alitava il ricordo indistinto non d’atti, non d’aspetti, ma quasi di desiderii prima svaniti che sorti; con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori, forse, che non han potuto sbocciare; il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere, là lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce; e non era nata; nella quale esso, lo spirito, allora, sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato; anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco a poco mi si chiusero, senza che me n’accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse, perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all’arrivo, mi ritrovai d’un tratto in tutt’altro animo, con un senso d’atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose piú consuete m’apparvero come votati di ogni senso, eppure, per i miei occhi, d’una gravezza crudele, insopportabile. Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa. *** Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. Spaventosamente d’un tratto mi s’impose la certezza, che l’uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuojo sotto il braccio, l’uomo che abitava là in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d’un tratto d’essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell’uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto; non ero mai stato nella vita; in una vita, intendo, che potessi riconoscer mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m’appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me; come se altri me l’avesse imposta e combinata, quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita, da cui ero stato sempre assente, atti di presenza, nei quali ora, improvvisamente, il mio spirito s’accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai! Chi lo aveva fatto così, quell’uomo che figurava me? chi lo aveva voluto così? chi così lo vestiva e lo calzava? chi lo faceva muovere e parlare così? chi gli aveva imposto tutti quei doveri uno piú gravoso e odioso dell’altro? Commendatore, professore, avvocato, quell’uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevan l’opera, il consiglio, l’assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro – ero io? io? propriamente? ma quando mai? E che m’importava di tutte le brighe in cui quell’uomo stava affogato dalla mattina alla sera; di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall’assiduo scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell’esercizio della sua professione? Ed erano lì, dietro quella porta che recava su la targa ovale d’ottone il mio nome, erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio ch’era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell’uomo insoffribile che dovevo esser io, e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia moglie? i miei figli? Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io (e lo sentivo con spaventosa certezza) quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta; di chi era moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei, no! Di quell’uomo, di quell’uomo che il mio spirito, in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti qua doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza, e anche la moglie, sì, fors’anche la moglie… Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No. Non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro; attraverso questo sentimento e col senso d’atroce afa col quale m’ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell’uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino; aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. *** Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chi sa di quanti! Chi vive, quando vive, non si vede: vive… Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive piú: la subisce, la trascina. Come una cosa morta, la trascina. Perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno; i piú, quasi tutti, lottano, s’affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma; raggiuntala, credono d’aver conquistato la loro vita, e cominciano invece a morire. Non lo sanno, perché non si vedono; perché non riescono a staccarsi piú da quella forma moribonda che hanno raggiunta; non si conoscono per morti e credono d’esser vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è piú in essa: perché se fosse, noi non la vedremmo: la vivremmo, questa forma, senza vederla. E morremmo ogni giorno di piú in essa, che è già per sì una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto; vedo che non sono mai stato vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c’è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un’anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l’anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia: – Ma come? io, questo? io, così? ma quando mai? – E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io; di questa forma morta, in cui sono prigioniero, e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri, che non sento miei, oppressa da brighe di cui non m’importa nulla, fatta segno d’una considerazione di cui non so che farmi; forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me: cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno piú respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto, e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu, comunque, hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi, dopo, negli atti compiuti; quello che hai fatto resta, come una prigione per te. E come spire e tentacoli t’avviluppano le conseguenze delle tue azioni. E ti grava attorno come un’aria densa, irrespirabile la responsabilità, che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute o non prevedute, ti sei assunta. E come puoi piú liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quali tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? una vita in una forma: che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l’hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti? Dev’essere questa, per forza. Serve così, a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m’hanno affidato la vita, l’onore, la libertà, gli averi. Serve così, e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi; ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l’atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che nessuno mi veda. Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaja. Tra me e lei non c’erano mai stati buoni rapporti. Forse, prima, essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa; s’era messa però ad approvarla a poco a poco, con la vecchiaja; tanto che, per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giú nel giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua, si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo, sì, caro: lavora; non ti muovere di lì, perché è sicuro che, finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno.» Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse, quindici giorni or sono, all’improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male; non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano, dal mio seggiolone, perché nessuno s’accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto e d’avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone; e in punta di piedi mi reco all’uscio a spiare nel corridojo, se qualcuno non sopravvenga; chiudo l’uscio a chiave, per un momento solo; gli occhi mi sfavillano di gioja, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi, d’esser pazzo, d’esser pazzo per un attimo solo, d’uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d’annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia; corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto; piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non piú, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere – ripeto – che non è nulla; che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende, la bestia, la terribilità dell’atto che compio. Non sarebbe nulla, se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo; e seguita maledettamente a guardarmi, atterrita. |
La giara
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
La giara è una novella che Pirandello scrisse nel 1906 e da cui trasse un atto unico per il teatro nel 1916. La novella fu pubblicata nella raccolta Novelle per un anno nel 1917.
Don Lollò, ricco proprietario terriero, tirchio attaccabrighe acquista una giara enorme. Ma la giara misteriosamente viene trovata rotta. Viene allora chiamato un artigiano, zi Dima per aggiustarla, ma … i due non sono d’accordo sulle modalità.
| Piena anche per gli olivi, quell’annata. Piante massaje, cariche l’anno avanti, avevano raffermato [confermato la loro solita produzione abbondante] tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. Lo Zirafa, che ne aveva un bel giro [una bella qualità] nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l’olio della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace [grande] a Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricavano: alta a petto d’uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa. Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là [padrone del forno in cui si cuoceva la terracotta] per questa giara. E con chi non attaccava [briga] Don Lollò Zirafa? Per ogni nonnulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca [filo] di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti [la denuncia]. Così, a furia di carta bollata e di onorari agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, s’era mezzo rovinato. Dicevano che il suo consulente legale, stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo di torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa: il codice, perché si scapasse [scervellasse] a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare. Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro gli gridavano: «Sellate la mula!» Ora, invece: «Consultate il calepino [codice]!» E Don Lollò rispondeva: «Sicuro, e vi fulmino tutti, figli d’un cane!» Quella giara nuova, pagata quattr’onze [monete d’oro] ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in cantina, fu allogata [sistemata] provvisoriamente nel palmento [magazzino]. Quella giara nuova, pagata quattr’onze [monete d’oro] ballanti e sonanti, in attesa del posto da trovarle in cantina, fu allogata [sistemata] provvisoriamente nel palmento [magazzino]. Una giara così non s’era mai veduta. Allogata in quell’antro intanfato [che puzzava] di mosto e di quell’odore acre e crudo che cova nei luoghi senz’aria e senza luce, faceva pena. Da due giorni era cominciata l’abbacchiatura [battitura dei rami di ulivo] delle olive, e Don Lollò era su tutte le furie perché, tra gli abbacchiatori e i mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi su la costa per la favata [semina delle fave] della nuova stagione, non sapeva più come spartirsi, a chi badar prima. E bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli, se un’oliva, che fosse un’oliva, gli fosse mancata, quasi le avesse prima contate tutte a una a una su gli alberi; o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri. Col cappellaccio bianco, in maniche di camicia, spettorato [con la camicia aperta sul torace], affocato [arrossato] in volto e tutto sgocciolante di sudore, correva di qua e di là, girando gli occhi lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase, su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasojo. Ora, alla fine della terza giornata, tre dei contadini che avevano abbacchiato, entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne, restarono [esterrefatti alla] vista della bella giara nuova, spaccata in due, come se qualcuno, con un taglio netto, prendendo tutta l’ampiezza della pancia, ne avesse staccato tutto il lembo davanti. «Guardate! guardate!» «Chi sarà stato?» «Oh mamma mia! E chi lo sente ora Don Lollò? La giara nuova, peccato!» Il primo, più spaurito di tutti, propose di riaccostar subito la porta e andare via zitti zitti, lasciando fuori, appoggiate al muro, le scale e le canne. Ma il secondo: «Siete pazzi? Con Don Lollò? Sarebbe capace di credere che gliel’abbiamo rotta noi. Fermi qua tutti!» Uscì davanti al palmento e, facendosi portavoce delle mani, chiamò: «Don Lollò! Ah, Don Lollòooo!» Eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime: gesticolava al solito furiosamente, dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco. Arrivava talvolta, a forza di quelle rincalcate, a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte. Già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo, e tra la pace che scendeva su la campagna con le ombre della sera e la dolce frescura, avventavano i gesti di quell’uomo sempre infuriato. «Don Lollò! Ah, Don Lollòoo!» Quando venne su e vide lo scempio, parve volesse impazzire. Si scagliò prima contro quei tre; ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro, gridando: «Sangue della Madonna, me la pagherete!» Afferrato a sua volta dagli altri due, stravolti nelle facce terrigne e bestiali, rivolse contro sé stesso la rabbia furibonda, sbatacchiò a terra il cappellaccio, si percosse le guance, pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto: «La giara nuova! Quattr’onze di giara! Non incignata [usata] ancora!» Voleva sapere chi gliel’avesse rotta! Possibile che si fosse rotta da sé? Qualcuno per forza doveva averla rotta, per infamità o per invidia! Ma quando? Ma come? Non si vedeva segno di violenza! Che fosse arrivata rotta dalla fabbrica? Ma che! Sonava come una campana! Appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta, cominciarono a esortarlo a calmarsi. La giara si poteva sanare. Non era poi rotta malamente. Un pezzo solo. Un bravo conciabrocche [artigiano che ripara le brocche e gli altri oggetti di terracotta] l’avrebbe rimessa su, nuova. C’era giusto Zi’ Dima Licasi, che aveva scoperto un mastice miracoloso, di cui serbava gelosamente il segreto: un mastice, che neanche il martello ci poteva [poteva romperla], quando aveva fatto presa. Ecco, se Don Lollò voleva, domani, alla punta dell’alba, Zi’ Dima Licasi sarebbe venuto lì e, in quattro e quattr’otto, [avrebbe aggiustato] la giara, meglio di prima. Don Lollò diceva di no, a quelle esortazioni: ch’era tutto inutile; che non c’era più rimedio; ma alla fine si lasciò persuadere, e il giorno appresso, all’alba, puntuale, si presentò a Primosole Zi’ Dima Licasi con la cesta degli attrezzi dietro le spalle. Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico d’olivo saraceno. Per cavargli una parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria [malinconia], o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o anche sconfidenza [sfiducia] che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d’inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, Zi’ Dima Licasi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro, perché non gli rubassero il segreto. «Fatemi vedere codesto mastice», gli disse per prima cosa Don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo, con diffidenza. Zi’ Dima negò col capo, pieno di dignità. «[quando la giara sarà] All’opera si vede». «Ma verrà bene?» Zi’ Dima posò a terra la cesta; ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato; prese a svolgerlo pian piano, tra l’attenzione e la curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un pajo d’occhiali col sellino e le stanghe rotti e legati con lo spago, lui sospirò e gli altri risero. Zi’ Dima non se ne curò; si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali; se li inforcò; poi si mise a esaminare con molta gravità la giara tratta su l’aja [nel cortile della fattoria]. Disse: «Verrà bene». «Col mastice solo però», disse per patto lo Zirafa, «non mi fido. Ci voglio anche i punti». «Me ne vado», rispose senz’altro Zi’ Dima, rizzandosi e rimettendosi la cesta dietro le spalle. Don Lollò lo acchiappò per un braccio. «Dove? Messere e porco, così trattate? Ma guarda un po’ che arie da Carlomagno! Scannato miserabile e pezzo d’asino, ci devo metter olio, io, là dentro, e l’olio trasuda! Un miglio di spaccatura, col mastice solo? Ci voglio i punti. Mastice e punti. Comando io». Zi’ Dima chiuse gli occhi, strinse le labbra e scosse il capo. Tutti così! Gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito, filato coscienziosamente a regola d’arte e di dare una prova della virtù del suo mastice. «Se la giara» disse «non suona di nuovo come una campana…» «Non sento niente», lo interruppe Don Lollò. «I punti! Pago mastice e punti. Quanto vi debbo dare?» «Se col mastice solo…» «Càzzica, che testa!» esclamò lo Zirafa. «Come parlo? V’ho detto che ci voglio i punti. C’intenderemo a lavoro finito: non ho tempo da perdere con voi». E se n’andò a badare ai suoi uomini. Zi’ Dima si mise all’opera gonfio d’ira e di dispetto. E l’ira e il dispetto gli crebbero a ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo staccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura. Accompagnava il frullo della saettella [il rumore del trapano] con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti; e il viso gli diventava più verde dalla bile e gli occhi più aguzzi e accesi di stizza. Finita quella prima operazione, scagliò con rabbia il trapano nella cesta; applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a egual distanza e in corrispondenza tra loro, poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzetti quant’erano i punti che doveva dare, e chiamò per ajuto uno dei contadini che abbacchiavano. «Coraggio, Zi’ Dima!» gli disse quello, vedendogli la faccia alterata. Zi’ Dima alzò la mano a un gesto rabbioso. Aprì la scatola di latta che conteneva il mastice, e lo levò al cielo, scotendolo, come per offrirlo a Dio, visto che gli uomini non volevano riconoscerne la virtù: poi col dito cominciò a spalmarlo tutt’in giro al lembo staccato e lungo la spaccatura; prese le tenaglie e i pezzetti di fil di ferro preparati avanti [prima], e si cacciò dentro la pancia aperta della giara, ordinando al contadino d’applicare il lembo alla giara, così come aveva fatto lui poc’anzi. Prima di cominciare a dare i punti: «Tira!» disse dall’interno della giara al contadino. «Tira con tutta la tua forza! Vedi se si stacca più? Malanno a chi non ci crede! Picchia, picchia! Suona, sì o no, come una campana, anche con me qua dentro? Va’, va’ a dirlo al tuo padrone!» «Chi è sopra comanda, Zi’ Dima», sospirò il contadino, «e chi è sotto si danna! Date i punti, date i punti». E Zi’ Dima si mise a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto, l’uno di qua e l’altro di là dalla saldatura; e con le tenaglie ne attorceva i due capi. Ci volle un’ora a passarli tutti. I sudori, giù a fontana, dentro la giara. Lavorando, si lagnava della sua mala sorte. E il contadino, di fuori, a confortarlo. «Ora ajutami a uscirne», disse alla fine Zi’ Dima. Ma quanto larga di pancia, tanto quella giara era stretta di collo. Zi’ Dima, nella rabbia, non ci aveva fatto caso. Ora, prova e riprova, non trovava più modo a uscirne. E il contadino, invece di dargli ajuto, eccolo là, si torceva dalle risa. Imprigionato, imprigionato nella giara da lui stesso sanata, e che ora «non c’era via di mezzo» per farlo uscire, doveva esser rotta daccapo e per sempre. Alle risa, alle grida, sopravvenne Don Lollò. Zi’ Dima, dentro la giara, era come un gatto inferocito. «Fatemi uscire!» urlava. «Corpo di Dio, voglio uscire! Subito! Datemi ajuto!» Don Lollò rimase dapprima come stordito. Non sapeva crederci. «Ma come? Là dentro? s’è cucito là dentro?» S’accostò alla giara e gridò al vecchio: «Ajuto? E che ajuto posso darvi io? Vecchiaccio stolido [stolto], ma come? non dovevate prender prima le misure? Su, provate: fuori un braccio … così! e la testa … su … no, piano! Che! giù … aspettate! così no! giù, giù … Ma come avete fatto? E la giara, adesso? Calma! Calma! Calma!» Si mise a raccomandare tutt’intorno, come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui. «Mi fuma la testa! Calma! Questo è caso nuovo … La mula!» Picchiò con le nocche delle dita su la giara. Sonava davvero come una campana. «Bella! Rimessa a nuovo … Aspettate!» disse al prigioniero. «Va’ a sellarmi la mula!» ordinò al contadino; e, grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: «Ma vedete un po’ che mi capita! Questa non è giara! Quest’è ordigno del diavolo! Fermo! Fermo lì! E accorse a regger la giara, in cui Zi’ Dima, furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola. «Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l’avvocato! Io non mi fido. La mula! La mula! Vado e torno, abbiate pazienza! Nell’interesse vostro … Intanto, piano! calma! Io mi guardo i miei. E prima di tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere. Ecco vi pago il lavoro, vi pago la giornata. Cinque lire. Vi bastano?» «Non voglio nulla!» gridò Zi’ Dima. «Voglio uscire!» «Uscirete. Ma io, intanto, vi pago. Qua, cinque lire.» Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara. Poi domandò, premuroso: «Avete fatto colazione? Pane e companatico, subito! Non ne volete? Buttatelo ai cani! A me basta che ve l’abbia dato». Ordinò che gli si desse; montò in sella, e via di galoppo per la città. Chi lo vide, credette che andasse a chiudersi da sé al manicomio, tanto e in così strano modo gesticolava. Per fortuna, non gli toccò di fare anticamera nello studio dell’avvocato; ma gli toccò d’attendere un bel po’, prima che questo finisse di ridere, quando gli ebbe esposto il caso. Delle risa si stizzì: «Che c’è da ridere, scusi? A vossignoria non brucia! La giara è mia!» Ma quello seguitava a ridere e voleva che gli rinarrasse il caso, com’era stato, per farci su altre risate. Dentro, eh? S’era, cucito dentro? E lui, Don Lollò, che pretendeva? Te … tene … tenerlo là dentro … ah ah ah … ohi ohi ohi … tenerlo là dentro per non perderci la giara?» «Ce la devo perdere?» domandò lo Zirafa con le pugna serrate. «Il danno e lo scorno [umiliazione]?» «Ma sapete come si chiama questo?» gli disse in fine l’avvocato. «Si chiama sequestro di persona!» «Sequestro? E chi l’ha sequestrato?» esclamò lo Zirafa. «S’è sequestrato lui da sé! Che colpa ne ho io?» L’avvocato allora gli spiegò che erano due casi. Da un canto, lui, Don Lollò, doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona; dall’altro, il conciabrocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine. «Ah!» rifiatò lo Zirafa. «Pagandomi la giara!» «Piano!» osservò l’avvocato. «Non come se fosse nuova, badiamo!» «E perché?» «Ma perché era rotta, oh bella!» «Rotta? Nossignore. Ora è sana. Meglio che sana, lo dice lui stesso! E se ora torno a romperla, non potrò più farla risanare. Giara perduta, signor avvocato!» L’avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto, facendogliela pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso. «Anzi», gli consigliò, «fatela stimare avanti da lui stesso». «Bacio le mani» disse Don Lollò, andando via di corsa. Di ritorno, verso sera, trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata. Partecipava alla festa anche il cane di guardia saltando e abbaiando. Zi’ Dima s’era calmato, non solo, ma aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con la gajezza mala dei tristi. Lo Zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara. «Ah! Ci stai bene?» «Benone. Al fresco» rispose quello. «Meglio che a casa mia». «Piacere. Intanto ti avverto che questa giara mi costò quattr’onze, nuova. Quanto credi che possa costare adesso?» «Con me qua dentro?» domandò Zi’ Dima. I villani risero. «Silenzio!» gridò lo Zirafa. «Delle due l’una: o il tuo mastice serve a qualche cosa, o non serve a nulla: se non serve a nulla, tu sei un imbroglione; se serve a qualche cosa, la giara, così com’è, deve avere il suo prezzo. Che prezzo? Stimala a tu». Zi’ Dima rimase un pezzo a riflettere, poi disse: «Rispondo. Se lei me l’avesse fatta conciare col mastice solo, com’io volevo, io, prima di tutto, non mi troverei qua dentro, e la giara avrebbe su per giù lo stesso prezzo di prima. Così sconciata con questi puntacci, che ho dovuto darle per forza di qua dentro, che prezzo potrà avere? Un terzo di quanto valeva, sì e no». «Un terzo?» domandò lo Zirafa. «Un’onza e trentatré?» «Meno sì, più no». «Ebbene», disse Don Lollò. «Passi la tua parola, e dammi un’onza e trentatré». «Che?» fece Zi’ Dima, come se non avesse inteso. «Rompo la giara per farti uscire», rispose Don Lollò, «e tu, dice l’avvocato, me la paghi per quanto l’hai stimata: un’onza e trentatré». «Io pagare?» sghignazzò Zi’ Dima. «Vossignoria scherza! Qua dentro ci faccio i vermi». E tratta di tasca con qualche stento la pipetta intartarita, l’accese e si mise a fumare, cacciando il fumo per il collo della giara. Don Lollò ci restò brutto [male]. Quest’altro caso, che Zi’ Dima ora non volesse più uscire dalla giara, né lui né l’avvocato l’avevano previsto. E come si risolveva adesso? Fu lì lì per ordinare di nuovo: «La mula!», ma pensò ch’era già sera. «Ah, sì» disse. «Ti vuoi domiciliare nella mia giara? Testimoni i tutti qua! Non vuole uscirne lui, per non pagarla; io sono pronto a romperla! Intanto, poiché vuole stare lì, domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l’uso della giara». Zi’ Dima cacciò prima fuori un’altra boccata di fumo, poi rispose, placido: «Nossignore. Non voglio impedirle niente, io. Sto forse qua per piacere? Mi faccia uscire, e me ne vado volentieri. Pagare … neanche per scherzo, vossignoria!» Don Lollò, in un impeto di rabbia, alzò un piede per avventare un calcio alla giara; ma si trattenne; la abbrancò invece con ambo le mani e la scrollò tutta, fremendo. «Vede che mastice?» gli disse Zi’ Dima. «Pezzo da galera!» ruggì allora lo Zirafa. «Chi l’ha fatto il male, io o tu? E devo pagarlo io? Muori di fame là dentro! Vedremo chi la vince!» E se n’andò, non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la giara. Con esse, per cominciare, Zi’ Dima pensò di far festa quella sera insieme coi contadini che, avendo fatto tardi per quello strano accidente, rimanevano a passare la notte in campagna, all’aperto, su l’aja. Uno andò a far le spese in una taverna lì presso. A farlo apposta, c’era una luna che pareva fosse giorno. A una cert’ora Don Lollò, andato a dormire, fu svegliato da un baccano d’inferno. S’affacciò a un balcone della cascina e vide su l’aja, sotto la luna, tanti diavoli: i contadini ubriachi che, presisi per mano, ballavano attorno alla giara. Zi’ Dima, là dentro, cantava a squarciagola. Questa volta non poté più reggere, Don Lollò: si precipitò come un toro infuriato e, prima che quelli avessero tempo di pararlo, con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa. Rotolando, accompagnata dalle risa degli ubriachi, la giara andò a spaccarsi contro un olivo. E la vinse Zi’ Dima. |
Se vuoi vedere la versione cinematografica, questa è tratta dal film Kaos dei fratelli Taviani. Buona visione.
https://www.raiplay.it/video/2016/11/Kaos-La-giara-2cfd67cb-0a9b-4471-823f-67a808e18ea5.html
Analisi del testo – La giara
La giara è un mitico oggetto di terracotta destinato a contenere una grande quantità di olio e a simboleggiare così l’abbondanza dell’annata. Attorno ad essa ruotano due mondi:
- quello ridente e festante dei contadini, pur consapevoli del loro ruolo di persone sottomesse ai padroni,
- quello dei due co-protagonisti, in perenne contrasto tra loro.
Si potrebbe dire che attraverso questi due personaggi Pirandello condensa il tema delle tante verità, dei tanti punti di vista attraverso i quali si svolgono gli eventi della vita.
Entrambi i personaggi, pur nella loro differente personalità, sono portavoce di un profondo disagio esistenziale:
- Don Lollò lo esprime attraverso la perenne ricerca della giustizia, attraverso le parole del suo avvocato o attraverso il calepino che gli è stato donato.
- Zi’ Dima, invece, è insoddisfatto della percezione che gli altri hanno di lui: mentre egli sa di aver inventato un mastice prodigioso, gli altri sembrano svalutare questo prodotto, non credendo alle sue proprietà.
Il riso che suscita il carattere petulante di Don Lollò di fronte all’assurda situazione di Zi’ Dima chiuso nella giara è solo un aspetto superficiale ed esteriore, che si collega al tema dell’umorismo di Pirandello.
La vicenda fa riflettere sul tema degli uomini perennemente alla ricerca di una logica degli eventi, che invece sfugge a qualsiasi analisi.
Alcuni critici hanno voluto identificare nella situazione di Zi’ Dima, prigioniero all’interno della giara, la condizione dell’uomo nella società, prigioniero di regole e leggi che lo soffocano. Altri ancora, nella costanza con cui egli sa attendere lo sviluppo degli eventi, provocando la stizza del suo antagonista, hanno voluto vedere la suprema libertà della vita, che supera qualsiasi regola astratta. La differenza delle interpretazioni ci riporta al ltema del relativismo pirandelliano.
Tecniche narrative
La novella ha uno sviluppo lineare; dopo un’introduzione che introduce alcuni elementi di contesto, come l’abbondanza dell’annata e alcune caratteristiche salienti della personalità di Don Lollò, il racconto si sviluppa dal tramonto di una giornata di lavoro fino alla notte del giorno successivo.
Molto spazio è dedicato alla rappresentazione dell’ambiente contadino siciliano nel momento dell’abbacchiatura delle olive, in autunno.
Ma molti particolari servono per mostrare le caratteristiche di uno dei due personaggi principali, Don Lollò Zirafa, iracondo e litigioso, sempre pronto a ricorrere al codice civile o all’avvocato per risolvere ogni problema.
A lui si contrappone il carattere chiuso, taciturno e cupo del conciabrocche, anch’egli per certi versi maniaco, torturato dalla scarsa fiducia che gli altri ripongono nel suo mastice.
Nella novella compare anche un personaggio corale, collettivo, quello dei contadini, che in questa novella sono rappresentati nella gioia dei momenti di festa, allietati da un bellissimo paesaggio. “A farlo apposta, c’era una luna che pareva fosse raggiornato“.
L’intreccio è vivace e svelto, giocato sulla sfida che si svolge tra Don Lollò e Zi’ Dima, una gara di intelligenza basata su un dialogo veloce e serrato, con un ritmo rapidissimo.
La lingua è ricca di aggettivi, molto varia, a tratti complessa, con aperture al registro giuridico e addirittura alla battuta scurrile.
Esercizi di scrittura
Rispondi a queste domande.
- Comprensione
- Chi è Don Lollò e per quale ragione compera una giara nuova?
- Che cosa succede alla giara nuova? Chi ne è il responsabile?
- Come si comporta Don Lollò quando si rende conto che la sua giara è rotta?
- Quale decisione viene presa?
- Qual è la posizione di Don Lollò relativamente alla procedura da seguire per riparare la giara?
- E qual è invece la posizione di Zi’ Dima?
- Chi dei due contendenti vince questa prima battaglia?
- Da chi si fa aiutare Zi’ Dima per mettere i punti alla giara?
- Come procede?
- Che cosa succede dopo?
- Che cosa pensa di fare Don Lollò per risolvere il problema?
- Come reagisce l’avvocato al racconto di Don Lollò e che cosa consiglia?
- Che cosa succede invece?
- Come si conclude la novella?
2. I personaggi di Don Lollò e Zi’ Dima sono diversi e perennemente in conflitto. Prova a descrivere le diverse caratteristiche di don Lollò e zì Dima ponendo l’attenzione ai caratteri fisici, agli atteggiamenti, al carattere, alla cultura e ai sentimenti e agli ideali che li muovono.
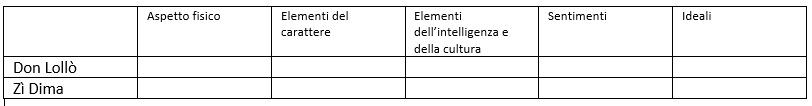
3. Ricostruisci schematicamente le diverse fasi dello scontro tra i due personaggi, citando per ogni fase una frase significativa tratta dal testo.
4. Nella novella viene data particolare importanza all’ambiente. Se dovessi scrivere qualcosa su questo tema, da quali passi del testo prenderesti spunto?
5. Come potresti definire la voce narrante della novella? Come giustifichi la tua scelta?
6. Rivedi la scena finale del racconto, quando Don Lollò, svegliato dal trambusto, vede sotto la luna i contadini ubriachi che ballano attorno alla giara. A chi vengono paragonati i contadini? Per quale ragione, a tuo parere?
7. Confronta l’ambiente contadino descritto nella novella con la rappresentazione che ne viene fornita da Verga nella novella La roba.
8. Quale dei due protagonisti ti piace di più? Per quale motivo?
9. Quali temi tipici della poetica di Pirandello sono presenti in questa novella?
La patente
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
Quando Chiàrchiaro, onesto padre di famiglia, viene additato come jettatore, perde il lavoro. la sua situazione è drammatica, la superstizione popolare sta mettendo in difficoltà la sua famiglia. Lui cerca una soluzione, cerca una via d’uscita, in modo … creativo.
A volte capita che nella vita qualcuno ci appiccichi addosso un’etichetta. Non sempre questo ci è gradito. In questa novella Pirandello ci mostra, con la sua sapiente penna, la via d’uscita alla spiacevolissima situazione in cui il protagonista Chiàrchiaro si era trovato, a causa della superstizione popolare.
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d’occhi e di mani, curvandosi, come chi regge rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere! Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant’anni; ma cose stranissime e quasi inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea. E pareva ch’egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera personcina. Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più triste, cioè di notte. Il giudice D’Andrea non poteva dormire. Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una di quelle stelle, e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l’anima a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sè una certezza su la quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul suo tavolino nell’ufficio d’Istruzione non lasciava mai dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese. Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d’amministrare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla così, su due piedi. Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi meditando la notte. Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice istruttore; così che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice istruttore. Eppure, per la prima volta, da circa una settimana, dormiva un incartamento sul tavolino del giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione smaniosa, a una tetraggine soffocante. Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a un certo punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice D’Andrea si metteva allora a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo. Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si ridestava e gli occhi gli andavano lì, a quell’angolo del tavolino dove giaceva l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le nari fischianti aria aria aria e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte dall’esasperazione, poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava una mano sul naso adunco a regger le lenti che, per il sudore, gli scivolavano. Era veramente iniquo quel processo là: iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi due che gli erano capitati sotto mano, e, sissignori, la giustizia doveva dargli torto, torto, torto, senza remissione, ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima. A passeggio cercava di parlarne coi colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del Chiàrchiaro, cioè di colui che aveva intentato il processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell’orologio. Qualcuno, più francamente, prorompeva: – Per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per avere un qualche lume dai colleghi – diceva – per discutere così in astratto il caso. Perché, in verità, era un caso insolito e speciosissimo quello d’un jettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli testimonii potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente? Come condannare, in coscienza, quei due giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri, e primi fra tutti – eccoli là – gli stessi giudici? E il D’Andrea si struggeva; si struggeva di più incontrando per via gli avvocati, nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti, l’esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo su la pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo majale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica festa» alle spalle d’un povero disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiàrchiaro per invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla querela, dimostrandogli quattro e quattr’otto che quei due giovanotti non potevano essere condannati, secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, perché questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appena alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: – Ma fatemi il piacere! Che storie son queste? Vergognatevi! Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: – Lei dunque non ci crede? – Ma fatemi il piacere! – ripeté il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua. E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: – Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, diventa cieco! Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: – Quando sarete comodo… Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c’è una sedia, sedete. Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. – Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla jettatura? Il D’Andrea sedette anche lui e disse: – Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così? – Nossignore, – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi non ammette scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo! – Questo sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. – Ma vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto. – Via? porto? Che porto e che via? – domandò, aggrondato, il Chiàrchiaro. – Né questa d’adesso, – rispose il D’Andrea, – né quella là del processo. Già l’una e l’altra scusate, son tra loro così. E il giudice D’Andrea infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. Il Chiàrchiaro si chinò e tra i due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito. – Non è vero niente, signor giudice! – disse, agitando quel dito. – Come no? – esclamò il D’Andrea. – Là accusate come diffamatori due giovani perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura. – Sissignore. – E non vi pare che ci sia contraddizione? Il Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. – Mi pare piuttosto, signor giudice, – poi disse, – che lei non capisca niente. Il D’Andrea lo guardò un pezzo, imbalordito. – Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente. – Sissignore. Eccomi qua, – disse il Chiàrchiaro, accostando la seggiola. – Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca? – Sì. Questo lo so. – Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto: cioè, che non solo mi ero accorto da più d’un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le prove anche, prove documentate e testimonianze irrepetibili dei fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice? La mia fama di jettatore! – Voi? Dal Baracca? – Sissignore, io. Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: – Capisco anche meno di prima. Ma come? Per render più sicura l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato? Il Chiàrchiaro ebbe un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio capitale! E ansimando, protese il braccio, batté forte sul pavimento la canna d’India e rimase un pezzo impostato in quell’atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté: Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne fai? che te ne fai? – Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto prender la laurea? – La laurea, sì. – Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. – E poi? – E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dello jettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! – Io? – Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città! Il giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. – Mi vuol bene davvero? – gli domandò – E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto quello che desidero. – La patente? Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d’India sul pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: – La patente. |
Video della novella interpretato da Totò
Esercizi di scrittura
- Delinea una descrizione del giudice D’Andrea.
- Che cosa toglie il sonno al giudice D’Andrea?
- Come lavora il giudice?
- Per quale motivo il D’Andrea non riesce ad evadere la pratica Chiarchiaro?
- Cosa pensa il giudice del Chiàrchiaro.
- Delinea una descrizione di Rosario Chiarchiaro.
- Che impressione ha fatto a te Chiarchiaro?
- Cosa ti ha colpito di questa novella?
- Quali temi tipici della poetica di Pirandello sono presenti in questa novella?
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
A Valdana si trasferiscono tre nuovi personaggi che improvvisamente catturano l’attenzione dell’intero paese. Il signor Ponza, sua moglie e la signora Frola, sua suocera, non vivono insieme, ma occupano due case diverse. Non solo, l’anziana signora non può accedere a casa del signor Ponza e per vedere sua figlia deve accontentarsi di lasciarle dei bigliettini in un paniere calato dalla ringhiera. Il narratore tenta di far chiarezza sul fatto, vissuto con inquietudine a Valdana, ricostruendo con attenzione le tre successive dichiarazioni rilasciate alle signore del paese da parte della signora Frola e del signor Ponza.
| Ma insomma, ve lo figurate? C’è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, suo genero. Cose che càpitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamìta di tutti i forestieri eccentrici! Pazza lei o pazzo lui; non c’è via di mezzo: uno dei due dev’esser pazzo per forza. Perché si tratta niente meno che di questo. Ma no, è meglio esporre prima con ordine. Sono, vi giuro, seriamente costernato dell’angoscia in cui vivono da tre mesi gli abitanti di Valdana, e poco m’importa della signora Frola e del signor Ponza, suo genero. Perché, se è vero che una grave sciagura è loro toccata, non è men vero che uno dei due, almeno, ha avuto la fortuna d’impazzirne e l’altro l’ha aiutato, seguita ad aiutarlo così che non si riesce, ripeto, a sapere quale dei due veramente sia pazzo; e certo una consolazione meglio di questa non se la potevano dare. Ma dico di tenere così, sotto quest’incubo, un’intera cittadinanza, vi par poco? togliendole ogni sostegno al giudizio, per modo che non possa più distinguere tra fantasma e realtà. Un’angoscia, un perpetuo sgomento. Ciascuno si vede davanti, ogni giorno, quei due; li guarda in faccia; sa che uno dei due è pazzo; li studia, li squadra, li spia e, niente! non poter scoprire quale dei due; dove sia il fantasma, dove la realtà. Naturalmente, nasce in ciascuno il sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma, e che ogni realtà può benissimo essere un fantasma e viceversa. Vi par poco? Nei panni del signor prefetto, io darei senz’altro, per la salute dell’anima degli abitanti di Valdana, lo sfratto alla signora Frola e al signor Ponza, suo genero. Ma procediamo con ordine. Questo signor Ponza arrivò a Valdana or sono tre mesi, segretario di prefettura. Prese alloggio nel casolare nuovo all’uscita del paese, quello che chiamano “il Favo”. Lì. All’ultimo piano, un quartierino. Tre finestre che danno sulla campagna, alte, tristi (ché la facciata di là, all’aria di tramontana, su tutti quegli orti pallidi, chi sa perché, benché nuova, s’è tanto intristita) e tre finestre interne, di qua, sul cortile, ove gira la ringhiera del ballatoio diviso da tramezzi a grate. Pendono da quella ringhiera, lassù lassù, tanti panierini pronti a esser calati col cordino a un bisogno. Nello stesso tempo, però, con meraviglia di tutti, il signor Ponza fissò nel centro della città, e propriamente in Via dei Santi n. 15, un altro quartierino ammobiliato di tre camere e cucina. Disse che doveva servire per la suocera, signora Frola. E difatti questa arrivò cinque o sei giorni dopo; e il signor Ponza si recò ad accoglierla, lui solo, alla stazione e la condusse e la lasciò lì, sola. Ora, via, si capisce che una figliuola, maritandosi, lasci la casa della madre per andare a convivere col marito, anche in un’altra città; ma che questa madre poi, non reggendo a star lontana dalla figliuola, lasci il suo paese, la sua casa, e la segua, e che nella città dove tanto la figliuola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte, questo non si capisce più facilmente; o si deve ammettere tra suocera e genero una così forte incompatibilità da rendere proprio impossibile la convivenza, anche in queste condizioni. Naturalmente a Valdana dapprima si pensò così. E certo chi scapitò per questo nell’opinione di tutti fu il signor Ponza. Della signora Frola, se qualcuno ammise che forse doveva averci anche lei un po’ di colpa, o per scarso compatimento o per qualche caparbietà o intolleranza, tutti considerarono l’amore materno che la traeva appresso alla figliuola, pur condannata a non poterle vivere accanto. Gran parte ebbe in questa considerazione per la signora Frola e nel concetto che subito del signor Ponza s’impresse nell’animo di tutti, che fosse cioè duro, anzi crudele, anche l’aspetto dei due, bisogna dirlo. Tozzo, senza collo, nero come un africano, con folti capelli ispidi su la fronte bassa, dense e aspre sopracciglia giunte, grossi mustacchi lucidi da questurino, e negli occhi cupi, fissi, quasi senza bianco, un’intensità violenta, esasperata, a stento contenuta, non si sa se di doglia tetra o di dispetto della vista altrui, il signor Ponza non è fatto certamente per conciliarsi la simpatia o la confidenza. Vecchina gracile, pallida, è invece la signora Frola, dai lineamenti fini, nobilissimi, e una aria malinconica, ma d’una malinconia senza peso, vaga e gentile, che non esclude l’affabilità con tutti. Ora di questa affabilità, naturalissima in lei, la signora Frola ha dato subito prova in città, e subito per essa nell’animo di tutti è cresciuta l’avversione per il signor Ponza; giacché chiaramente è apparsa a ognuno l’indole di lei, non solo mite, remissiva, tollerante, ma anche piena d’indulgente compatimento per il male che il genero le fa; e anche perché s’è venuto a sapere che non basta al signor Ponza relegare in una casa a parte quella povera madre, ma spinge la crudeltà fino a vietarle anche la vista della figliuola. Se non che, non crudeltà, protesta subito nelle sue visite alle signore di Valdana la signora Frola, ponendo le manine avanti, veramente afflitta che si possa pensare questo di suo genero. E s’affretta a decantarne tutte le virtù, a dirne tutto il bene possibile e immaginabile; quale amore, quante cure, quali attenzioni egli abbia per la figliuola, non solo, ma anche per lei, sì, sì, anche per lei; premuroso, disinteressato. Ah, non crudele, no, per carità! C’è solo questo: che vuole tutta, tutta per sé la mogliettina, il signor Ponza, fino al punto che anche l’amore, che questa deve avere (e l’ammette, come no?) per la sua mamma, vuole che le arrivi non direttamente, ma attraverso lui, per mezzo di lui, ecco. Sì, può parere crudeltà, questa, ma non lo è; è un’altra cosa, un’altra cosa ch’ella, la signora Frola, intende benissimo e si strugge di non sapere esprimere. Natura, ecco. ma no, forse una specie di malattia. come dire? Mio Dio, basta guardarlo negli occhi. Fanno in prima una brutta impressione, forse, quegli occhi; ma dicono tutto a chi, come lei, sappia leggere in essi: la pienezza chiusa, dicono, di tutto un mondo d’amore in lui, nel quale la moglie deve vivere senza mai uscirne minimamente, e nel quale nessun altro, neppure la madre, deve entrare. Gelosia? Sì, forse; ma a voler definire volgarmente questa totalità esclusiva d’amore. Egoismo? Ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo, alla propria donna! Egoismo, in fondo, sarebbe quello di lei a voler forzare questo mondo chiuso d’amore, a volervisi introdurre per forza, quand’ella sa che la figliuola è felice, così adorata. Questo a una madre può bastare! Del resto, non è mica vero ch’ella non la veda, la sua figliuola. Due o tre volte al giorno la vede: entra nel cortile della casa; suona il campanello e subito la sua figliuola s’affaccia di lassù. – Come stai Tildina? – Benissimo, mamma. Tu? – Come Dio vuole, figliuola mia. Giù, giù il panierino! E nel panierino, sempre due parole di lettera, con le notizie della giornata. Ecco, le basta questo. Dura ormai da quattr’anni questa vita, e ci s’è abituata la signora Frola. Rassegnata, sì. E quasi non ne soffre più. Com’è facile intendere, questa rassegnazione della signora Frola, quest’abitudine ch’ella dice d’aver fatto al suo martirio, ridondano a carico del signor Ponza, suo genero, tanto più, quanto più ella col suo lungo discorso si affanna a scusarlo. Con vera indignazione perciò, e anche dirò con paura, le signore di Valdana che hanno ricevuto la prima visita della signora Frola, accolgono il giorno dopo l’annunzio di un’altra visita inattesa, del signor Ponza, che le prega di concedergli due soli minuti d’udienza, per una “doverosa dichiarazione”, se non reca loro incomodo. Affocato in volto, quasi congestionato, con gli occhi più duri e più tetri che mai, un fazzoletto in mano che stride per la sua bianchezza, insieme coi polsini e il colletto della camicia, sul nero della carnagione, del pelame e del vestito, il signor Ponza, asciugandosi di continuo il sudore che gli sgocciola dalla fronte bassa e dalle gote raschiose e violacee, non già per il caldo, ma per la violenza evidentissima dello sforzo che fa su se stesso e per cui anche le grosse mani dalle unghie lunghe gli tremano; in questo e in quel salotto, davanti a quelle signore che lo mirano quasi atterrite, domanda prima se la signora Frola, sua suocera, è stata a visita da loro il giorno avanti; poi, con pena, con sforzo, con agitazione di punto in punto crescenti, se ella ha parlato loro della figliuola e se ha detto che egli le vieta assolutamente di vederla e di salire in casa sua. Le signore, nel vederlo così agitato, com’è facile immaginare, s’affrettano a rispondergli che la signora Frola, sì, è vero, ha detto loro di quella proibizione di vedere la figlia, ma anche tutto il bene possibile e immaginabile di lui, fino a scusarlo, non solo, ma anche a non dargli nessun’ombra di colpa per quella proibizione stessa. Se non che, invece di quietarsi, a questa risposta delle signore, il signor Ponza si agita di più; gli occhi gli diventano più duri, più fissi, più tetri; le grosse gocce di sudore più spesse; e alla fine, facendo uno sforzo ancor più violento su se stesso, viene alla sua “dichiarazione doverosa”. La quale è questa, semplicemente: che la signora Frola, poveretta, non pare, ma è pazza. Pazza da quattro anni, sì. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che egli non voglia farle vedere la figliuola. Quale figliuola? È morta, è morta da quattro anni la figliuola: e la signora Frola, appunto per il dolore di questa morte, è impazzita: per fortuna, impazzita, sì, giacché la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva scamparne, se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta e che sia lui, invece, suo genero, che non vuole più fargliela vedere. Per puro dovere di carità verso un’infelice, egli, il signor Ponza, seconda da quattro anni, a costo di molti e gravi sacrifici, questa pietosa follia: tiene, con dispendio superiore alle sue forze, due case: una per sé, una per lei; e obbliga la sua seconda moglie, che per fortuna caritatevolmente si presta volentieri, a secondare anche lei questa follia. Ma carità, dovere, ecco, fino a un certo punto: anche per la sua qualità di pubblico funzionario, il signor Ponza non può permettere che si creda di lui, in città, questa cosa crudele e inverosimile: ch’egli cioè, per gelosia o per altro, vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola. Dichiarato questo, il signor Ponza s’inchina innanzi allo sbalordimento delle signore, e va via. Ma questo sbalordimento delle signore non ha neppure il tempo di scemare un po’, che rieccoti la signora Frola con la sua aria dolce di vaga malinconia a domandare scusa se, per causa sua, le buone signore si sono prese qualche spavento per la visita del signor Ponza, suo genero. E la signora Frola, con la maggior semplicità e naturalezza del mondo, dichiara a sua volta, ma in gran confidenza, per carità! poiché il signor Ponza è un pubblico funzionario, e appunto per questo ella la prima volta s’è astenuta dal dirlo, ma sì, perché questo potrebbe seriamente pregiudicarlo nella carriera; il signor Ponza, poveretto – ottimo, ottimo inappuntabile segretario alla prefettura, compìto, preciso in tutti i suoi atti, in tutti i suoi pensieri, pieno di tante buone qualità – il signor Ponza, poveretto, su quest’unico punto non. non ragiona più, ecco; il pazzo è lui, poveretto; e la sua pazzia consiste appunto in questo: nel credere che sua moglie sia morta da quattro anni e nell’andar dicendo che la pazza è lei, la signora Frola che crede ancora viva la figliuola. No, non lo fa per contestare in certo qual modo innanzi agli altri quella sua gelosia quasi maniaca e quella crudele proibizione a lei di vedere la figliuola, no; crede, crede sul serio il poveretto che sua moglie sia morta e che questa che ha con sé sia una seconda moglie. Caso pietosissimo! Perché veramente col suo troppo amore quest’uomo rischiò in prima di distruggere, d’uccidere la giovane mogliettina delicatina, tanto che si dovette sottrargliela di nascosto e chiuderla a insaputa di lui in una casa di salute. Ebbene, il povero uomo, a cui già per quella frenesia d’amore s’era anche gravemente alterato il cervello, ne impazzì; credette che la moglie fosse morta davvero: e questa idea gli si fissò talmente nel cervello, che non ci fu più verso di levargliela, neppure quando, ritornata dopo circa un anno florida come prima, la mogliettina gli fu ripresentata. La credette un’altra; tanto che si dovette con l’aiuto di tutti, parenti e amici, simulare un secondo matrimonio, che gli ha ridato pienamente l’equilibrio delle facoltà mentali. Ora la signora Frola crede d’aver qualche ragione di sospettare che da un pezzo suo genero sia del tutto rientrato in sé e ch’egli finga, finga soltanto di credere che sua moglie sia una seconda moglie, per tenersela così tutta per sé, senza contatto con nessuno, perché forse tuttavia di tanto in tanto gli balena la paura che di nuovo gli possa esser sottratta nascostamente. Ma sì. Come spiegare, se no, tutte le cure, le premure che ha per lei, sua suocera, se veramente egli crede che è una seconda moglie quella che ha con sé? Non dovrebbe sentire l’obbligo di tanti riguardi per una che, di fatto, non sarebbe più sua suocera, è vero? Questo, si badi, la signora Frola lo dice, non per dimostrare ancor meglio che il pazzo è lui; ma per provare anche a sé stessa che il suo sospetto è fondato. – E intanto, – conclude con un sospiro che su le labbra le s’atteggia in un dolce mestissimo sorriso, – intanto la povera figliuola mia deve fingere di non esser lei, ma un’altra, e anch’io sono obbligata a fingermi pazza credendo che la mia figliuola sia ancora viva. Mi costa poco, grazie a Dio, perché è là, la mia figliuola, sana e piena di vita; la vedo, le parlo; ma sono condannata a non poter convivere con lei, e anche a vederla e a parlarle da lontano, perché egli possa credere, o fingere di credere che la mia figliuola, Dio liberi, è morta e che questa che ha con sé è una seconda moglie. Ma torno a dire, che importa se con questo siamo riusciti a ridare la pace a tutti e due? So che la mia figliuola è adorata, contenta; la vedo; le parlo; e mi rassegno per amore di lei e di lui a vivere così e a passare anche per pazza, signora mia, pazienza. Dico, non vi sembra che a Valdana ci sia proprio da restare a bocca aperta, a guardarci tutti negli occhi, come insensati? A chi credere dei due? Chi è il pazzo? Dov’è la realtà? dove il fantasma? Lo potrebbe dire la moglie del signor Ponza. Ma non c’è da fidarsi se, davanti a lui, costei dice d’esser seconda moglie; come non c’è da fidarsi se, davanti alla signora Frola, conferma d’esserne la figliuola. Si dovrebbe prenderla a parte e farle dire a quattr’occhi la verità. Non è possibile. Il signor Ponza – sia o no lui il pazzo – è realmente gelosissimo e non lascia vedere la moglie a nessuno. La tiene lassù, come in prigione, sotto chiave; e questo fatto è senza dubbio in favore della signora Frola; ma il signor Ponza dice che è costretto a far così, e che sua moglie stessa anzi glielo impone, per paura che la signora Frola non le entri in casa all’improvviso. Può essere una scusa. Sta anche di fatto che il signor Ponza non tiene neanche una serva in casa. Dice che lo fa per risparmio, obbligato com’è a pagar l’affitto di due case; e si sobbarca intanto a farsi da sé la spesa giornaliera, e la moglie, che a suo dire non è la figlia della signora Frola, si sobbarca anche lei per pietà di questa, cioè d’una povera vecchia che fu suocera di suo marito, a badare a tutte le faccende di casa, anche alle più umili, privandosi dell’aiuto di una serva. Sembra a tutti un po’ troppo. Ma è anche vero che questo stato di cose, se non con la pietà, può spiegarsi con la gelosia di lui. Intanto, il signor Prefetto di Valdana s’è contentato della dichiarazione del signor Ponza. Ma certo l’aspetto e in gran parte la condotta di costui non depongono in suo favore, almeno per le signore di Valdana più propense tutte quante a prestar fede alla signora Frola. Questa, difatti, viene premurosa a mostrar loro le letterine affettuose che le cala giù col panierino la figliuola, e anche tant’altri privati documenti, a cui però il signor Ponza toglie ogni credito, dicendo che le sono stati rilasciati per confortare il pietoso inganno. Certo è questo, a ogni modo: che dimostrano tutt’e due, l’uno per l’altra, un meraviglioso spirito di sacrificio, commoventissimo; e che ciascuno ha per la presunta pazzia dell’altro la considerazione più squisitamente pietosa. Ragionano tutt’e due a meraviglia; tanto che a Valdana non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di dire che l’uno dei due era pazzo, se non l’avessero detto loro: il signor Ponza della signora Frola, e la signora Frola del signor Ponza. La signora Frola va spesso a trovare il genero alla prefettura per aver da lui qualche consiglio, o lo aspetta all’uscita per farsi accompagnare in qualche compera: e spessissimo, dal canto suo, nelle ore libere e ogni sera il signor Ponza va a trovare la signora Frola nel quartierino ammobiliato; e ogni qual volta per caso l’uno s’imbatte nell’altra per via, subito con la massima cordialità si mettono insieme; egli le dà la destra e, se stanca, le porge il braccio, e vanno così, insieme, tra il dispetto aggrondato e lo stupore e la costernazione della gente che li studia, li squadra, li spia e, niente!, non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà. |
Pensaci Giacomino!
Clicca qui per vedere il video in cui viene letto il testo della novella.
C’è una realtà che sembra quello che non è …
La novella racconta le vicende dell’anziano professore di liceo, Agostino Toti, che ha ricevuto un’eredità da un lontano parente. L’uomo decide di sposare la giovane Maddalena, figlia del bidello della scuola. La donna ha una relazione con Giacomino Delisi, ex allievo del professore …
| Da tre giorni il professore Agostino Toti non ha in casa quella pace, quel riso, a cui crede ormai di aver diritto. Ha circa settant’anni, e dir che sia un bel vecchio, non si potrebbe neanche dire: piccoletto, con la testa grossa, calva, senza collo, il torso sproporzionato su due gambettine da uccello. Sì, sì: il professor Toti lo sa bene, e non si fa la minima illusione, perciò, che Maddalena, la bella mogliettina, che non ha ancora ventisei anni, lo possa amare per se stesso. È vero che egli se l’è presa povera e l’ha innalzata: figliuola del bidello del liceo, è diventata moglie d’un professore ordinario di scienze naturali, tra pochi mesi con diritto al massimo della pensione; non solo, ma ricco anche da due anni per una fortuna impensata, per una vera manna dal cielo: una eredità di quasi duecentomila lire, da parte d’un fratello spatriato da tanto tempo in Rumenia e morto celibe colà. Non per tutto questo però il professor Toti crede d’aver diritto alla pace e al riso. Egli è filosofo: sa che tutto questo non può bastare a una moglie giovine e bella. Se l’eredità fosse venuta prima del matrimonio, egli magari avrebbe potuto pretendere da Maddalenina un po’ di pazienza, che aspettasse cioè la morte di lui non lontana per rifarsi del sacrifizio d’aver sposato un vecchio. Ma son venute troppo tardi, ahimè! quelle duecentomila lire, due anni dopo il matrimonio, quando già … quando già il professor Toti filosoficamente aveva riconosciuto, che non poteva bastare a compensare il sacrifizio della moglie la sola pensioncina ch’egli le avrebbe un giorno lasciata. Avendo già concesso tutto prima, il professor Toti crede d’aver più che mai ragione di pretendere la pace e il riso ora, con l’aggiunta di quell’eredità vistosa. Tanto più, poi, in quanto egli – uomo saggio veramente e dabbene – non si è contentato di beneficiar la moglie, ma ha voluto anche beneficiare … sì, lui, il suo buon Giacomino, già tra i più valenti alunni suoi al liceo, giovane timido, onesto, garbatissimo, biondo, bello e ricciuto come un angelo. Ma sì, ma sì – ha fatto tutto, ha pensato a tutto il vecchio professore Agostino Toti. Giacomino Delisi era sfaccendato, e l’ozio lo addolorava e lo avviliva; ebbene, lui, il professor Toti, gli ha trovato posto nella Banca Agricola, dove ha collocato le duecentomila lire dell’eredità. C’è anche un bambino, ora, per casa, un angioletto di due anni e mezzo, a cui egli si è dedicato tutto, come uno schiavo innamorato. Ogni giorno, non gli par l’ora che finiscano le lezioni al liceo per correre a casa, a soddisfare tutti i capriccetti del suo piccolo tiranno. Veramente, dopo l’eredità, egli avrebbe potuto mettersi a riposo, rinunziando a quel massimo della pensione, per consacrare tutto il suo tempo al bambino. Ma no! Sarebbe stato un peccato! Dacché c’è, egli vuol portare fino all’ultimo quella sua croce, che gli è stata sempre tanto gravosa! Se ha preso moglie proprio per questo, proprio perché recasse un beneficio a qualcuno ciò che per lui è stato un tormento tutta la vita! Sposando con quest’unico intento, di beneficare una povera giovine, egli ha amato la moglie quasi paternamente soltanto. E più che mai paternamente s’è messo ad amarla, da che è nato quel bambino, da cui quasi quasi gli piacerebbe più d’esser chiamato nonno, che papà. Questa bugia incosciente sui puri labbruzzi del bambino ignaro gli fa pena; gli pare che anche il suo amore per lui ne resti offeso. Ma come si fa? Bisogna pure che si prenda con un bacio quell’appellativo dalla boccuccia di Ninì, quel «papà» che fa ridere tutti i maligni, i quali non sanno capire la tenerezza sua per quell’innocente, la sua felicità per il bene che ha fatto e che seguita a fare a una donna, a un buon giovinotto, al piccino, e anche a sé – sicuro! – anche a sé – la felicità di vivere quegli ultimi anni in lieta e dolce compagnia, camminando per la fossa così, con un angioletto per mano. Ridano, ridano pure di lui tutti i maligni! Che risate facili! che risate sciocche! Perché non capiscono. Perché non si mettono al suo posto. Avvertono soltanto il comico, anzi il grottesco, della sua situazione, senza saper penetrare nel suo sentimento! Ebbene, che glie n’importa? Egli è felice. Se non che, da tre giorni … Che sarà accaduto? La moglie ha gli occhi gonfii e rossi di pianto; accusa un forte mal di capo; non vuole uscir di camera. – Eh, gioventù! … gioventù! … – sospira il professor Toti, scrollando il capo con un risolino mesto e arguto negli occhi e sulle labbra. – Qualche nuvola … qualche temporaletto … E con Ninì s’aggira per casa, afflitto, inquieto, anche un po’ irritato, perché … via, proprio non si merita questo, lui, dalla moglie e da Giacomino. I giovani non contano i giorni: ne hanno tanti ancora innanzi a sé . Ma per un povero vecchio è grave perdita un giorno! E sono ormai tre, che la moglie lo lascia così per casa, come una mosca senza capo, e non lo delizia più con quelle ariette e canzoncine cantate con la vocetta limpida e fervida, e non gli prodiga più quelle cure, a cui egli è ormai avvezzo. Anche Ninì è serio serio, come se capisca che la mamma non ha testa da badare a lui. Il professore se lo conduce da una stanza all’altra, e quasi non ha bisogno di chinarsi per dargli la mano, tant’è piccolino anche lui; lo porta innanzi al pianoforte, tocca qua e là qualche tasto, sbuffa, sbadiglia, poi siede, fa galoppare un po’ Ninì su le ginocchia, poi torna ad alzarsi: si sente tra le spine. Cinque o sei volte ha tentato di forzar la mogliettina a parlare. – Male, eh? ti senti proprio male? Maddalenina seguita a non volergli dir nulla: piange; lo prega di accostar gli scuri del balcone e di portarsi Ninì di là: vuole star sola e al bujo. – Il capo, eh? Poverina, le fa tanto male il capo … Eh, la lite dev’essere stata grossa davvero! Il professor Toti si reca in cucina e cerca d’abbordar la servetta, per avere qualche notizia da lei; ma fa larghi giri, perché sa che la servetta gli è nemica; sparla di lui, fuori, come tutti gli altri, e lo mette in berlina, brutta scema! Non riesce a saper nulla neanche da lei. E allora il professor Toti prende una risoluzione eroica: reca Ninì dalla mamma e la prega che glielo vesta per benino. – Perché? – domanda ella. – Lo porto a spassino, – risponde lui. – Oggi è festa … Qua s’annoja, povero bimbo! La mamma non vorrebbe. Sa che la trista gente ride vedendo il vecchio professore col piccino per mano; sa che qualche malvagio insolente è arrivato finanche a dirgli: – Ma quanto gli somiglia, professore, il suo figliuolo! Il professor Toti però insiste. – No, a spassino, a spassino … E si reca col bimbo in casa di Giacomino Delisi. Questi abita insieme con una sorella nubile, che gli ha fatto da madre. Ignorando la ragione del beneficio, la signorina Agata era prima molto grata al professor Toti; ora invece – religiosissima com’è – lo tiene in conto d’un diavolo, né più ne meno, perché ha indotto il suo Giacomino in peccato mortale. Il professor Toti deve aspettare un bel po’, col piccino, dietro la porta, dopo aver sonato. La signorina Agata è venuta a guardar dalla spia ed è scappata. Senza dubbio, è andata ad avvertire il fratello della visita, e ora tornerà a dire che Giacomino non è in casa. Eccola. Vestita di nero, cerea, con le occhiaje livide, stecchita, arcigna, appena aperta la porta, investe, tutta vibrante, il professore. – Ma come … scusi … viene a cercarlo pure in casa adesso? … E che vedo! anche col bambino? ha condotto anche il bambino? Il professor Toti non s’aspetta una simile accoglienza; resta intronato; guarda la signorina Agata, guarda il piccino, sorride, balbetta: – Per … perché? … che è? … non posso … non … posso venire a … – Non c’è! – s’affretta a rispondere quella, asciutta e dura. – Giacomino non c’è. – Va bene, – dice, chinando il capo, il professor Toti. – Ma lei, signorina … mi scusi … Lei mi tratta in un modo che … non so! Io non credo d’aver fatto né a suo fratello, né a lei … – Ecco, professore, – lo interrompe, un po’ rabbonita, la signorina Agata. – Noi, creda pure, le siamo … le siamo riconoscentissimi; ma anche lei dovrebbe comprendere … Il professor Toti socchiude gli occhi, torna a sorridere, alza una mano e poi si tocca parecchie volte con la punta delle dita il petto, per significarle che, quanto a comprendere, lasci fare a lui. – Sono vecchio, signorina, – dice, – e comprendo … tante cose comprendo io! e guardi, prima di tutte, questa: che certe furie bisogna lasciarle svaporare, e che, quando nascono malintesi, la miglior cosa è chiarire … chiarire, signorina, chiarire francamente, senza sotterfugi, senza riscaldarsi … Non le pare? – Certo, sì … – riconosce, almeno così in astratto, la signorina Agata. – E dunque, – riprende il professor Toti, – mi lasci entrare e mi chiami Giacomino. – Ma se non c’è! – Vede? No, Non mi deve dire che non c’è. Giacomino è in casa, e lei me lo deve chiamare. Chiariremo tutto con calma … glielo dica: con calma! Io sono vecchio e comprendo tutto, perché sono stato anche giovane, signorina. Con calma, glielo dica. Mi lasci entrare. Introdotto nel modesto salotto, il professor Toti siede con Ninì tra le gambe, rassegnato ad aspettare anche qua un bel pezzo, che la sorella persuada Giacomino. – No, qua Ninì … buono! – dice di tratto in tratto al bimbo, che vorrebbe andare a una mensoletta, dove luccicano certi gingilli di porcellana; e intanto si scapa a pensare che diamine può essere accaduto di così grave in casa sua, senza ch’egli se ne sia accorto per nulla. Maddalenina è così buona! Che male può ella aver fatto, da provocare un così aspro e forte risentimento, qua, anche nella sorella di Giacomino? Il professor Toti, che ha creduto finora a una bizza passeggera, comincia a impensierirsi e a costernarsi sul serio. Oh, ecco Giacomino finalmente! Dio, che viso alterato! che aria rabbuffata! Eh come? Ah, questo no! Scansa freddamente il bambino che gli è corso incontro gridando con le manine tese: – «Giamì! Giamì!». – Giacomino! – esclama, ferito, con severità, il professor Toti. – Che ha da dirmi, professore? – s’affretta a domandargli quello, schivando di guardarlo negli occhi. – Io sto male … Ero a letto … Non sono in grado di parlare e neanche di sostener la vista d’alcuno … – Ma il bambino?! – Ecco, – dice Giacomino; e si china a baciare Ninì. – Ti senti male? – riprende il professor Toti, un po’ racconsolato da quel bacio. – Lo supponevo. E son venuto per questo. Il capo, eh? Siedi, siedi … Discorriamo. Qua, Ninì … Senti che «Giamì» ha la bua? Sì, caro, la bua … qua, povero «Giami» … Sta’ bonino; ora andiamo via. Volevo domandarti – soggiunge, rivolgendosi a Giacomino, – se il direttore della Banca Agricola ti ha detto qualche cosa. – No, perché? – fa Giacomino, turbandosi ancor più. – Perché jeri gli ho parlato di te, – risponde con un risolino misterioso il professor Toti. Il tuo stipendio non è molto grasso, figliuol mio. E sai che una mia parolina … Giacomino si torce su la sedia, stringe le pugna fino ad affondarsi le unghie nel palmo delle mani. – Professore, io la ringrazio, – dice, – ma mi faccia il favore, la carità, di non incomodarsi più per me, ecco! – Ah sì? – risponde il professor Toti con quel risolino ancora su la bocca. – Bravo! Non abbiamo più bisogno di nessuno, eh? Ma se io volessi farlo per mio piacere? Caro mio, ma se non debbo più curarmi di te, di chi vuoi che mi curi io? Sono vecchio, Giacomino! E ai vecchi – badiamo, che non siano egoisti! – ai vecchi, che hanno tanto stentato, come me, a prendere uno stato, piace di vedere i giovani, come te meritevoli, farsi avanti nella vita per loro mezzo; e godono della loro allegria, delle loro speranze, del posto ch’essi prendono man mano nella società. Io poi per te … via, tu lo sai … ti considero come un figliuolo … Che cos’è? Piangi? Giacomino ha nascosto infatti il volto tra le mani e sussulta come per un impeto di pianto che vorrebbe frenare. Ninì lo guarda sbigottito, poi, rivolgendosi al professore, dice: – «Giamì, bua» . Il professore si alza e fa per posare una mano su la spalla di Giacomino; ma questi balza in piedi, quasi ne provi ribrezzo, mostra il viso scontraffatto come per una fiera risoluzione improvvisa, e gli grida esasperatamente: – Non mi s’accosti! Professore, se ne vada, la scongiuro, se ne vada! Lei mi sta facendo soffrire una pena d’inferno! Io non merito codesto suo affetto e non lo voglio, non lo voglio . Per carità, se ne vada, si porti via il bambino e si scordi che io esisto! Il professor Toti resta sbalordito; domanda: – Ma perché? – Glielo dico subito! – risponde Giacomino. – Io sono fidanzato, professore! Ha capito? Sono fidanzato! Il professor Toti vacilla, come per una mazzata sul capo; alza le mani; balbetta: – Tu? fi . fidanzato? – Sissignore, – dice Giacomino. – E dunque, basta . basta per sempre! Capirà che non posso più … vederla qui … – Mi cacci via? – domanda, quasi senza voce, il professor Toti. – No! – s’affretta a rispondergli Giacomino, dolente. – Ma è bene che lei … che lei se ne vada, professore . Andarsene? Il professore casca a sedere su la seggiola. Le gambe gli si sono come stroncate sotto. Si prende la testa tra le mani e geme: – Oh Dio! Ah che rovina! Dunque per questo? Oh povero me! Oh povero me! Ma quando? come? senza dirne nulla? con chi ti sei fidanzato? – Qua, professore … da un pezzo … – dice Giacomino. – con una povera orfana, come me … amica di mia sorella . Il professor Toti lo guarda, inebetito, con gli occhi spenti, la bocca aperta, e non trova la voce per parlare. – E … e … e si lascia tutto … così … e … e non si pensa più a … a nulla … non si … non si tien più conto di nulla . Giacomino si sente rinfacciare con queste parole l’ingratitudine, e si ribella, fosco: – Ma scusi! che mi voleva schiavo, lei? – Io, schiavo? – prorompe, ora, con uno schianto nella voce, il professor Toti. – Io? E lo puoi dire? Io che ti ho fatto padrone della mia casa? Ah, questa, questa sì che è vera ingratitudine! E che forse t’ho beneficato per me? che ne ho avuto io, se non il dileggio di tutti gli sciocchi che non sanno capire il sentimento mio? Dunque non lo capisci, non lo hai capito neanche tu, il sentimento di questo povero vecchio, che sta per andarsene e che era tranquillo e contento di lasciar tutto a posto, una famigliuola bene avviata, in buone condizioni … felice? Io ho settant’anni; io domani me ne vado, Giacomino! Che ti sei levato di cervello, figliuolo mio! Io vi lascio tutto, qua … Che vai cercando? Non so ancora, non voglio saper chi sia la tua fidanzata; se l’hai scelta tu, sarà magari un’onesta giovine, perché tu sei buono …; ma pensa che … pensa che … non è possibile che tu abbia trovato di meglio. Giacomino, sotto tutti i riguardi … Non ti dico soltanto per l’agiatezza assicurata … Ma tu hai già la tua famigliuola, in cui non ci sono che io solo di più, ancora per poco … io che non conto per nulla … Che fastidio vi do io? Io sono come il padre … Io posso anche, se volete … per la vostra pace … Ma dimmi com’è stato? che è accaduto? come ti s’è voltata la testa, così tutt’a un tratto? Dimmelo! dimmelo … E il professor Toti s’accosta a Giacomino e vuol prendergli un braccio e scuoterglielo; ma quegli si restringe tutto in sé, quasi rabbrividendo, e si schermisce. – Professore! – grida. – Ma come non capisce, come non s’accorge che tutta codesta sua bontà … – Ebbene? – Mi lasci stare! non mi faccia dire! Come non capisce che certe cose si possono far solo di nascosto, e non son più possibili alla luce, con lei che sa, con tutta la gente che ride? – Ah, per la gente? – esclama il professore. – E tu … – Mi lasci stare! – ripete Giacomino, al colmo dell’orgasmo, scotendo in aria le braccia. – Guardi! Ci sono tant’altri giovani che han bisogno d’ajuto, professore! Il Toti si sente ferire fin nell’anima da queste parole, che sono un’offesa atroce e ingiusta per sua moglie; impallidisce, allividisce, e tutto tremante dice: – Maddalenina è giovine, ma è onesta, perdio! e tu lo sai! Maddalenina ne può morire … perché è qui, è qui, il suo male, nel cuore … dove credi che sia? È qui, è qui, ingrato! Ah, la insulti, per giunta? E non ti vergogni? e non ne senti rimorso di fronte a me? Puoi dirmi questo in faccia? tu? Credi che ella possa passare, così, da uno all’altro, come niente? madre di questo piccino? Ma che dici? Come puoi parlar così? Giacomino lo guarda trasecolato, allibito. – Io? – dice. – Ma lei piuttosto, professore, scusi, lei, lei, come può parlare così? Ma dice sul serio? Il professor Toti si stringe ambo le mani su la bocca, strizza gli occhi, squassa il capo e rompe in un pianto disperato. Ninì anche lui, allora, si mette a piangere. Il professore lo sente, corre a lui, lo abbraccia. – Ah, povero Ninì mio . ah che sciagura, Ninì mio, che rovina! E che sarà della tua mamma ora? e che sarà di te, Ninì mio, con una mammina come la tua, inesperta, senza guida … Ah, che baratro! Solleva il capo, e, guardando tra le lagrime Giacomino: – Piango, – dice, – perché mio è il rimorso; io t’ho protetto, io t’ho accolto in casa, io le ho parlato sempre tanto bene di te, io . io le ho tolto ogni scrupolo d’amarti … e ora che ella ti amava sicura … madre di questo piccino … tu … S’interrompe e, fiero, risoluto, convulso: – Bada, Giacomino! – dice. – Io son capace di presentarmi con questo piccino per mano in casa della tua fidanzata! Giacomino, che suda freddo, pur su la brace ardente, nel sentirlo parlare e piangere così, a questa minaccia giunge le mani, gli si fa innanzi e scongiura: – Professore, professore, ma lei vuol dunque proprio coprirsi di ridicolo? – Di ridicolo? – grida il professore. – E che vuoi che me n’importi, quando vedo la rovina d’una povera donna, la rovina tua, la rovina d’una creatura innocente? Vieni, vieni, andiamo, su via, Ninì, andiamo! Giacomino gli si para davanti: – Professore, lei non lo farà! – Io lo farò! – gli grida con viso fermo il professor Toti. – E per impedirti il matrimonio son anche capace di farti cacciare dalla Banca! Ti do tre giorni di tempo. E, voltandosi su la soglia, col piccino per mano: – Pensaci, Giacomino! Pensaci! |
Fonti
- M. Magri, V. Vittorini, Tre, Paravia.
- B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LETTERAUTORI © Zanichelli 2011
- www.libraryweschool.com